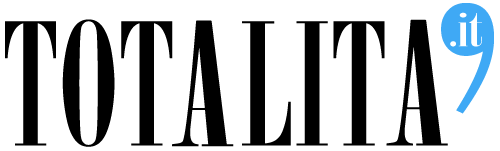Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.
Editoriale
Università telematiche e il pericolo della distopia orwelliana
Il presidente di Confindutria lancia l'allarme sulla scarsa qualità dei laureati in atenei telematici

di Simonetta Bartolini
 eggendo le legittime critiche che il presidente di Confindustria Emanuele Orsini aveva fatto alle università telematiche, avevo provato un moto di vera e sincera riconoscenza. Il mondo imprenditoriale lanciava un grido di allarme riguardo alla formazione universitaria invocando la necessità di eccellenza.
eggendo le legittime critiche che il presidente di Confindustria Emanuele Orsini aveva fatto alle università telematiche, avevo provato un moto di vera e sincera riconoscenza. Il mondo imprenditoriale lanciava un grido di allarme riguardo alla formazione universitaria invocando la necessità di eccellenza.
Leggendo poi l’intervento di Carlo Lottieri sul «Giornale» che dava voce alle rimostranze del mondo universitario telematico lo sconforto è tornato sovrano, anche se comprendo quanto esso sia dettato da una altrettanto legittima difesa d’ufficio.
Il discorso sull’università e sui mali che la affliggono sarebbe lungo e penoso, ma basta leggere il libro di Galli della Loggia, Berardelli e Perla, Università addio per avere un’idea di come metter mano al problema. Quindi procedo per punti rispetto alla difesa delle università telematiche fatta da Lottieri.
Giustamente si dice che le telematiche erano nate per offrire, a coloro già inseriti nel mondo del lavoro, la possibilità di compiere un percorso formativo superiore che magari permettesse di avere un avanzamento in carriera, o più frecce in faretra per migliorarsi. Intento lodevole e finanche benemerito. Ma guardiamo i numeri: nel 2024 l’11,5% degli studenti risulta iscritto ad un’università telematica con un incremento del 7% negli ultimi dieci anni. Sorge spontanea una domanda: in un decennio abbiamo avuto un numero così significativo di persone che avendo un lavoro volevano prendere una laura che non avevano? Può darsi, ma non ci sono dati che ci dicano quanti studenti lavoratori e quanti studenti liberi da impegni si iscrivano alle telematiche. Il sospetto è che molti studenti preferiscano l’iscrizione ad una telematica perché presenta notevoli vantaggi, fra i quali costi meno elevati, maggiore semplicità nel sostenere gli esami e risultati più certi. Insomma, si ha il sospetto che si preferisca la minima spesa (non solo in termini economici) e la massima resa (risultato quasi garantito). Che poi si trasformi in minima spesa minima resa (qualitativa) ormai sembra non interessi a nessuno, da qui l’allarme del Presidente di Confindustria.
Lottieri e i difensori d’ufficio delle università telematiche, affermano che “una delle ragioni della bassa produttività italiana risiede nel limitato numero di laureati”: curioso che il presidente di Confindustria non ci abbia fatto caso. È altresì curioso che, vista la lamentata penuria di laureati, ce ne siano tanti senza occupazione. Viene il sospetto che il mondo imprenditoriale abbia bisogno di quell’eccellenza invocata da Orsini ma definita da Lottieri “difesa dell’esistente”.
Appunto l’eccellenza. È vero che è difficile fare gerarchie di valore assoluto, anche se i dati dell’ANVUR riguardo agli atenei italiani relegano le università telematiche in posizioni non esattamente da primato (dati del Corsera del 2 aprile 2025 e più recentemente sulla «Stampa» il 21 luglio 2025).
Ma a prescindere da ciò la didattica basata su lezioni preregistrate difficilmente formerà un eccellente laureato. L’insegnamento universitario non è istruzione, ma formazione al sapere, acquisizione di strumenti atti a interpretare la complessità. E questo difficilmente potrà avvenire fornendo ai discenti un tutorial per maneggiare la bibliografia di un insegnamento.
Le lezioni on line sono di fatto audio-video-bignami accompagnati da slide (le uniche che lo studente finisce per studiare ignorando i libri di testo), il cui apprendimento spesso viene verificato attraverso test a crocette (comprensibile visto il rapporto docenti/studenti, 1 a 385).
Chi scrive insegna in un corso di studi tradizionale e in uno telematico e, stante i lievi numeri di quello telematico, può fare esami tradizionali. La differenza purtroppo si vede. Perché una lezione universitaria non è fatta solo di nozioni, riflessioni, approfondimenti preconfezionati (allora basterebbero i libri, potremmo abolire le lezioni e verificare la conoscenza della bibliografia). Una lezione universitaria è fatta anche di continuo confronto con la quotidianità, con il mondo che ci circonda, con la complessità con cui il sapere deve confrontarsi. È fatta di dialogo docente /discente è fatta di scambio continuo, e anche, sì diciamolo, di empatia. È necessario adeguare la propria lezione agli studenti che ti trovi davanti senza per questo immiserirne la qualità ma certamente cercando una corrispondenza con chi ascolta.
Non basta, e parlo per la materia che insegno, conoscere tutto su uno scrittore e sulla sua opera, se chi li ha studiati a lungo (e questo dovrebbe essere il ruolo del professore universitario) non porta, per esempio, lo studente a verificarne l’attualità e dunque la forza, l’importanza e la necessità di conoscerli con il continuo confronto con il mondo che ci circonda.
Per non parlare naturalmente dell’esiguità oraria di un corso telematico dove la necessità di ascolto e riascolto, oltre alla naturale caduta dell’attenzione molto più rapida di fronte a qualcosa di preregistrato, riduce di fatto il numero di ore dedicate a quell’insegnamento rispetto ad una lezione in presenza.
Sulla «Stampa» leggiamo che un burlone (non può essere altrimenti) addirittura si augura che anche nelle cosiddette scuole dell’obbligo si passi alla didattica su piattaforma.
Certo risolveremmo molti problemi economici perché con il sistema telematico l’insegnante sarà necessario solo la prima volta, quando dovrà registrare le lezioni, poi l’anno successivo con poche ore di assistenza (all’università si chiamano e-tivities) qualche interrogazione (rigorosamente con test a crocette) si potrà ridurre drasticamente il numero dei docenti e magari, per giustificare lo stipendio, visto che non faranno più lezione, impiegarli a sbrigare pratiche burocratiche (quelle tanto non mancano mai). Se ne gioverebbe anche l’edilizia scolastica che non si troverebbe più a fare i conti con tetti che fanno acqua (quando non crollano) o aule troppo fredde in inverno o troppo calde in estate. Ancora un magnifico risparmio!
Potrebbe accadere, ma il burlone di cui sopra non ci pensa perché appunto parlava per burla, che alleveremmo generazioni di zombie capaci solo di interloquire con un computer (altro che hikikomori!), ma di fronte alle magnifiche sorti e progressive per i laudatores della tecnologia e della cosiddetta intelligenza artificiale questo deve sembrare un lieve prezzo da pagare.
Nello stesso modo sarebbe simpatico capire come se la caverebbero le famiglie che demandano alla scuola la sorveglianza e la sistemazione logistica dei figli quando i genitori sono al lavoro. O come se la caverebbero quei tanti che vivono in abitazioni troppo piccole per gestire l’interazione studente computer. La pandemia ci ha insegnato quanti problemi sono sorti per le famiglie quando le scuole erano chiuse e le lezioni si svolgevano a distanza.
Per favore, non scherziamo, la scuola e l’università sono (o dovrebbero essere cose serie) e questa difesa delle nuove tecnologie da applicare indiscriminatamente in qualunque campo, compreso quello dove l’essere l’umano e la sua capacità fanno la differenza, è un vero e/orrore.
Immaginare generazioni di studenti (per ora universitari) formati davanti ad un computer assomiglia molto, troppo alla distopia del romanzo di Orwell – vi ricordate i teleschermi che guidavano la società?
Un totalitarismo tecnologico che annulla la libertà di essere umani.
Piaciuto questo Articolo? Condividilo...
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:24:03
88952634'
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:23:59
88952634'||'
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:23:55
88952634'
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:23:49
88952634'+'
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:23:45
88952634s3
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:23:38
88952634-0
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:23:31
88952634'`"(
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:23:12
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:23:09
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:23:05
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:23:01
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:22:58
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:22:54
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:22:50
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:22:47
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:22:43
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:22:39
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:22:36
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:22:32
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:22:25
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:22:22
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:22:18
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:22:14
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:22:11
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:22:07
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:22:03
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:22:00
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:21:53
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:21:49
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:21:43
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:21:39
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:21:35
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:21:32
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:21:28
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:21:21
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:21:15
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:21:11
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:21:04
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:20:58
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:20:51
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:20:47
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:20:38
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:20:13
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:20:07
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:20:03
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:19:56
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:19:53
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:19:49
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:19:45
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:19:41
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:19:35
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:19:31
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:19:27
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:19:24
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:19:20
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:19:16
88952634
-
Inserito da 88952634' il 18/12/2025 08:19:13
88952634
-
Inserito da 88952634'||' il 18/12/2025 08:19:10
88952634
-
Inserito da 88952634' il 18/12/2025 08:19:07
88952634
-
Inserito da 88952634'+' il 18/12/2025 08:19:02
88952634
-
Inserito da 88952634s3 il 18/12/2025 08:18:58
88952634
-
Inserito da 88952634-0 il 18/12/2025 08:18:54
88952634
-
Inserito da 88952634'`"( il 18/12/2025 08:18:51
88952634
-
Inserito da 88952634 il 18/12/2025 08:18:47
88952634
-
Inserito da sgmold il 03/12/2025 03:32:14
-
Inserito da fatima il 29/11/2025 18:21:01
Ciao Cerchi un prestito di emergenza? Qualsiasi: Per rilanciare le tue attività finanziarie? Per ristrutturare l'interno del tuo appartamento; casa; edilizia? Per una concessione? Per comprare un'auto? Prestito per matrimonio? Per saldare un debito? Per realizzare un progetto? O per altri motivi, ecc... Offerta di prestito interindividuale. Ti offro un prestito da 2.000 a 800.000 € con condizioni molto semplici al tasso del 3%. Faccio anche investimenti e prestiti interindividuali di tutti i tipi. Offro prestiti a breve, medio e lungo termine. Grazie. Contattaci via email: veronicaberlusconi846@gmail.com
-
Inserito da kpupwr2 il 27/11/2025 03:31:05
tokyo mohoo box 的設計靈感來源於東京璀璨的夜景。其主機外觀簡潔俐落,線條流暢並具科技感,加上多種顏色可供選擇,讓使用者可以依照自己的風格自由搭配。
-
Inserito da kpupwr2 il 27/11/2025 03:30:00
Mohoo Box——一個聽起來神秘又富含藝術氣息的名字,如今已成為電子菸愛好者間炙手可熱的話題。
-
Inserito da kpupwr2 il 27/11/2025 03:28:51
隨著KISS電子煙 https://www.kis5-hk.com/ 的熱銷,市場上也出現了大量的仿冒品。本文將分享幾個有效的技巧,幫助消費者辨別KISS電子煙的真假,確保購買到正品,保障使用安全和體驗 https://www.remaxstore.com.tw/all-url/ 品質。
-
Inserito da yXvA il 20/11/2025 02:51:25
ZNDN
-
Inserito da yXvA il 20/11/2025 02:51:24
ZNDN
-
Inserito da yXvA il 20/11/2025 02:51:23
ZNDN
-
Inserito da yXvA il 20/11/2025 02:51:22
ZNDN
-
Inserito da yXvA il 20/11/2025 02:51:21
ZNDN
-
Inserito da yXvA il 20/11/2025 02:51:19
ZNDN
-
Inserito da yXvA il 20/11/2025 02:51:18
ZNDN
-
Inserito da yXvA il 20/11/2025 02:51:16
ZNDN
-
Inserito da yXvA il 20/11/2025 02:51:15
ZNDN
-
Inserito da yXvA il 20/11/2025 02:51:14
ZNDN
-
Inserito da ahr147 il 11/11/2025 07:28:39
บุหรี่ไฟฟ้า relx relx infinity relx infinity plus ร้านขายหัวพอต relx ใกล้ฉัน ราคาบุหรี่ไฟฟ้า relx zero relx artisan relx บุหรี่ไฟฟ้า relx เยว่เค่อ เยว่เค่อ บุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า relx ซื้อบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ เยว่เค่อ บุหรี่ไฟฟ้า relex เยว่เค่อ relx บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง RELX ของแท้ เครื่อง RELX รุ่นล่าสุด RELX บุหรี่ไฟฟ้า ราคาถูก เครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้า พอตไฟฟ้า relx เครื่องบุหรี่ไฟฟ้า ราคาถูก รสชาติหัวพอต RELX หัวพอต RELX แนะนำรสชาติหัวพอต RELX หัวพอต relx หัวพอต relx ประเทศไทย รสชาติบุหรี่ไฟฟ้า หัวพอตบุหรี่ไฟฟ้า relx รุ่น 5 relx รุ่นห้า relx รุ่น 5 ตัวเครื่อง relx รุ่นห้า ตัวเครื่อง หัวพอด relx รุ่น 5 หัวพอด relx รุ่นห้า relx รุ่น 6 relx รุ่นหก เครื่อง relx รุ่น 6 เครื่องรุ่นหก relx เครื่องรุ่น 6 ของ relx เครื่อง relx รุ่นหก เครื่องรุ่นหกของ relx หัวน้ำยา relx รุ่น 6 หัวน้ำยารุ่น 6 ของ relx หัวน้ำยา relx รุ่นหก หัวน้ำยา relx 6 รุ่น หัวน้ำยา relx 6代 adidas samba nike air force 1 nike dunk samba adidas originals yeezy 愛 迪 達 鞋子 nike sacai nike 鞋子 nike vomero 5 nike x sacai nike 拖鞋 nike sneakers nike zoom vomero 5 yeezy slides
-
Inserito da https://loadslot.net/ il 08/11/2025 11:28:48
Easy to crack slot website 2025, big promotion for all members. Ready to provide service via website 24 hours a day. https://loadslot.net/
-
Inserito da https://sbobetcasino338a.org/ il 08/11/2025 11:28:33
New system slots Choose to play every slot game camp Choose to bet for fun with a direct website. https://sbobetcasino338a.org/
-
Inserito da https://casinoonlinebonus668.com/ il 08/11/2025 11:28:17
Choose to play slots with a direct website. Play online slots, fun and fun, easy to make profits with the rhythm of winning. Get the big prize. https://casinoonlinebonus668.com/
-
Inserito da https://prevenzionenoslot.org/ il 08/11/2025 11:22:15
Direct web slots, online slots website that can be verified There is no history of cheating at all. Plus there are promotions for members. https://prevenzionenoslot.org/
-
Inserito da https://sexxx4all.com/ il 08/11/2025 11:22:00
Come in first, play first, get rich first. Traveling players can try playing slots for free, receive pg slot promotions, and get a chance to win free credit. https://sexxx4all.com/
-
Inserito da https://bigcasinos.info/ il 08/11/2025 11:21:46
Invite players to experience the fun of playing online slot games, direct website slots, with all pg slot games to choose from. Including famous camps leading worldwide https://bigcasinos.info/
-
Inserito da https://casinoenligne24.org/ il 08/11/2025 11:21:31
If you want to play slots that are easy to break and make a profit quickly, we recommend you to get to know the slots website that is easy to break. Direct entrance to play on the website. https://casinoenligne24.org/
-
Inserito da https://casinoactiononline.com/ il 08/11/2025 11:21:13
Discover the special features of playing slot games. Ready for you to experience the ultimate fun. Direct web slots are open to interested players. https://casinoactiononline.com/
-
Inserito da https://casino2win.net/ il 08/11/2025 11:20:57
Enter to play online slots directly, online slots, easy to break slots, many players https://casino2win.net/
-
Inserito da https://mirzslot.com/ il 08/11/2025 11:20:35
Including the most popular slots, new game slots, easy-to-break slots, and many slot games. PG Slot, pg slots, full of broken slots. Let every gambler choose from many forms of fun https://mirzslot.com/
-
Inserito da Laura Belmonte il 20/10/2025 18:21:20
Buongiorno avresti bisogno di liquidità immediata ? puoi fare la vostra richiesta inviando un messaggio : teresacamelata@gmail.com Buongiorno avresti bisogno di liquidità immediata ? puoi fare la vostra richiesta inviando un messaggio : teresacamelata@gmail.com Buongiorno avresti bisogno di liquidità immediata ? puoi fare la vostra richiesta inviando un messaggio : teresacamelata@gmail.com Buongiorno avresti bisogno di liquidità immediata ? puoi fare la vostra richiesta inviando un messaggio : teresacamelata@gmail.com Buongiorno avresti bisogno di liquidità immediata ? puoi fare la vostra richiesta inviando un messaggio : teresacamelata@gmail.com Buongiorno avresti bisogno di liquidità immediata ? puoi fare la vostra richiesta inviando un messaggio : teresacamelata@gmail.com Buongiorno avresti bisogno di liquidità immediata ? puoi fare la vostra richiesta inviando un messaggio : teresacamelata@gmail.com Buongiorno avresti bisogno di liquidità immediata ? puoi fare la vostra richiesta inviando un messaggio : teresacamelata@gmail.com Buongiorno avresti bisogno di liquidità immediata ? puoi fare la vostra richiesta inviando un messaggio : teresacamelata@gmail.com Buongiorno avresti bisogno di liquidità immediata ? puoi fare la vostra richiesta inviando un messaggio : teresacamelata@gmail.com Buongiorno avresti bisogno di liquidità immediata ? puoi fare la vostra richiesta inviando un messaggio : teresacamelata@gmail.com Buongiorno avresti bisogno di liquidità immediata ? puoi fare la vostra richiesta inviando un messaggio : teresacamelata@gmail.com
-
Inserito da Laura Belmonte il 20/10/2025 18:19:15
Buongiorno avresti bisogno di liquidità immediata ? puoi fare la vostra richiesta inviando un messaggio : teresacamelata@gmail.com
-
Inserito da gael il 09/10/2025 06:02:00
Prestito molto affidabile. Ti aiuto a ottenere un finanziamento rapido e affidabile. Quindi, se hai bisogno di soldi urgentemente, contattami per fornirti i dettagli. Email: gaelgaletti@gmail.com WhatsApp +393501704945
-
Inserito da gael il 09/10/2025 06:00:57
Prestito molto affidabile. Ti aiuto a ottenere un finanziamento rapido e affidabile. Quindi, se hai bisogno di soldi urgentemente, contattami per fornirti i dettagli. Email: gaelgaletti@gmail.com WhatsApp +393501704945
-
Inserito da ทดลองเล่นสล็อตฟรี il 26/08/2025 11:26:26
ทดลองเล่นสล็อตฟรี ในยุคที่เกมส์สล็อตออนไลน์ มีองค์ประกอบหลายๆอย่าง ที่เป็นตัวทำให้นักลงทุน ตัดสินใจกับการเล่นเกมสล็อตจาก เว็บนี้ มากกว่าที่อื่นๆ การทดลองเล่นสล็อตฟรี ทำให้ผู้เล่นติดใจ และ กลับมาเล่นกับ สล็อตเว็บตรง ที่นี่ ซ้ำ
-
Inserito da ทดลองเล่นสล็อต il 26/08/2025 11:25:57
ทดลองเล่นสล็อต เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ มีทดลองเล่นสล็อตฟรี เป็นแหล่งรวมตัวเกมส์ สล็อตยอดฮิต แตกหนัก แตกดี ที่สำคัญคือ การเลือกเว็บสล็อตสายตรงไม่ผ่านเเย่นต์ เชื่อถือได้มั่นคงปลอดภัยแน่นอน และ ตัวเกมส์สล็อตยอดฮิต ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับนักลงทุนเช่นกัน
-
Inserito da รวมโปรสล็อต50% il 26/08/2025 11:25:37
รวมโปรสล็อต50% เป็นหนึ่งในจุดขายของค่ายเกมนี้ เป็น สล็อตเว็บตรง อันดับ1หลายแห่งในไทย และ ต่างประเทศ โดยไม่ผ่านเอเย่นต์ ผู้เล่นจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย และ อัตราการจ่ายที่ยุติธรรม รวมโปรสล็อต จากเว็บตรงนี้ มีรวมเกมทุกค่าย ที่ผ่านการตรวจสอบ จากองค์กรเกมระดับโลก ทำให้ผู้เล่นมีความมั่นใจว่า เล่นแล้วได้เงินจริง ไม่มีล็อคยูสแน่นอน!
-
Inserito da เกมยิงปลา il 26/08/2025 11:25:17
เกมยิงปลา ในวงการออนไลน์ นอกจาก สล็อตออนไลน์แล้ว ยังมี คาสิโนออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเดิมพันเป็นจำนวนมาก สล็อตเว็บตรง ที่มี รวมเกมยิงปลาทุกค่าย ที่เป็นยอดนิยมอีกด้วย ไม่ได้แค่เพราะความสนุกและความตื่นเต้นในการเล่น ยังเป็นเกมที่มีภาพกราฟิกสวยงามอลังการ และสามารถทำกำไรได้จริง ด้วยฝีมือและกลยุทธ์ที่ดี เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และสายล่าโบนัส
-
Inserito da รวมโปรสล็อต pg 50% il 26/08/2025 11:24:52
รวมโปรสล็อต pg 50% เป็นหนึ่งในจุดขายของค่ายเกมนี้ เป็นโปรโมชั่น จากสล็อตเว็บตรง อันดับ1หลายแห่งในไทย และ ต่างประเทศ โดยไม่ผ่านเอเย่นต์ ผู้เล่นจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย และ อัตราการจ่ายที่ยุติธรรม ค่ายเกมนี้ ยังผ่านการตรวจสอบ จากองค์กรเกมระดับโลก ทำให้ผู้เล่นมีความมั่นใจว่า รวมโปรสล็อต pg 50% นี้ เล่นแล้วได้เงินจริง ไม่มีล็อคยูสแน่นอน!
-
Inserito da Jeffreyabnob il 15/08/2025 00:02:42
https://t.me/s/onewin_kanal
-
Inserito da juhf il 22/07/2025 18:23:43
non esiste la possibilità di modificare un messaggio visto che scrivendo di fretta possono capitare errori di grammatica?
-
Inserito da juhf il 22/07/2025 18:17:47
il suo mi pare l'ennesimo articolo pieno esclusivamente di pregiudizi,personalmente ho fato esami a crocette in un'università in presenza ed esami a domande aperte(dovendo studiare sui libri) in una telematica. ancora più assurdo il discorso sul confronto visto che è possibile solo nei corsi con pochi frequentanti,nelle grandi università pubbliche spesso la prima e ultima volta che lo studente interagisce col professore è durante l'esame
102 commenti per questo articolo
il Banditore
Non possiamo nn dirci conservatori, e allora attenti con la santificazione della tecnologia
Quel che la Corte Suprema non ha considerando riguardo al divorzio
Perché la destra sta sparendo dall'agone politico
Mettete la museruola ai genitori incoscienti
Se le donne vincono quando in politica i migliori rinunciano
Editoriale
Terremoti, risate e ipocrisia
1995-2015 An, dopo l'illusione di una destra al governo il fallimento per manifesta incapacità
Lo tsunami Cofferati e lo struzzo Renzi
Tutti gli errori di Berlusconi pagati nei sondaggi che premiano la Lega
Quell'odioso doppiopesismo che elegge l'ipocrisia a sistema di giudizio