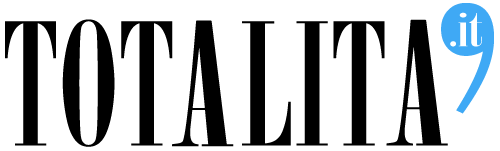Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.
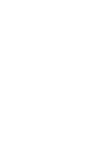
Maggio Musicale Fiorentino
UNO E TRINO: il trittico di Puccini finalmente al completo in scena al Maggio Musicale
Parte stasera Venerdì 15 novembre l'edizione del capolavoro pucciniano, per la regia di Denis Krief e la direzione di Valerio Galli. Tutte le recite dedicate alla memoria di Rolando Panerai.
di Domenico Del Nero

Un'immagine delle prove del Gianni Schicchi.
In principio doveva essere tutto Dante. All’indomani di Tosca Giacomo Puccini elabora (1900) un progetto tanto intrigante quanto certo difficile: tre opere in un atto, una per ciascuna cantica della Commedia. Poi però, pochi anni dopo, virata di bordo sulla Russia, cercando ispirazione nientemeno che in alcuni racconti di Gorky ( tra l’altro uno di essi, la zattera, è per certi aspetti simile nella trama al Tabarro ) ma non riesce a decidersi. Poi però nel 1910 vi fu Fanciulla del West e il compositore lucchese non tornò all’apparentemente bizzarro progetto di tre opere brevi in un’unica sera se non nel periodo tra il 1912 e il 1916, anche se non è facile capire come i “tre pezzi” prendono posto.
Nel 1912, Puccini assiste (almeno così pare) all’atto unico di Didier Gold la Houppelande (il Tabarro), un soggetto decisamente “nero” che gli offre lo spunto per il pannello tragico della sua trilogia. Nel 1912 “ci riprova” con D’Annunzio: la storia della fallita collaborazione tra i due ha connotati decisamente comici: in realtà erano due temperamenti antitetici e Puccini era persino convinto che l’Immaginifico portasse iella. Comunque sia nel 1912 gli scrive “Trovami 2 0 3 (meglio) atti teatrali, animati da tutte le corde sensibili – piccoli atti – di dolci e piccole cose e persone… la tua sirenetta! Lascia alla parte visiva un grande campo, metti in azione quanti personaggi vuoi …” Ma la Sirenetta del Vate si rivelerà sempre troppo ingombrante per Puccini, che nel 1913 affida il libretto del Tabarro a Ferdinando Martini che però non soddisfa l’esigentissimo palato del maestro e così l’incarico passa a Giuseppe Adami. Il Tabarro sarà ultimato solo nel 1916, dopo la Rondine .
Nel 1917 Giovacchino Forzano (1883-1970) un geniale e poliedrico autore di teatro di Borgo San Lorenzo, offre a Puccini uno schema di sua creazione per Suor Angelicaed è lui ad avere l’idea “dantesca” per il terzo pannello, Gianni Schicchi. Tra il marzo e il settembre del 1917 compone così la seconda opera, il momento “mistico” della sua trilogia e tra l’estate del 1917 e i primi mesi del 1918 lo Schicchi. La prima rappresentazione fu il 14 dicembre 1918 a New York, prima italiano pochi giorni dopo, l’11 gennaio 1919, al Costanzi di Roma. In entrambi i casi, il successo maggiore toccò allo Schicchi, mentre in America Suor Angelica fu giudicata (del tutto a torto) addirittura un fallimento,
Esiste un forte filo conduttore tra le tre opere, o sono completamente staccate? Riccardo Chailly osserva che la maledizione del Trittico “E’ stata l’autorizzazione d’autore, sollecitata e reiterata da Ricordi, all’esecuzione staccata dei titoli, distruggendo l’unitarietà intima del lavoro, la sua natura di triplice riflessione sul tema della morte”. Della stessa opinione era già stato Enzo Siciliano, anche se l’aneddotica pucciniana ci spingerebbe a pensare il contrario, raccontandoci di come la denominazione di Trittico venne fuori all’indomani di una serata “goliardica” con alcuni amici tra cui Forzano, in cui dopo proposte assurde quali treppiede e trisulco, dopo una serratissima discussione venne fuori Trittico e a dar retta a Puccini non piaceva a nessuno. Ma Trittico fu …
Ma
con buona pace dell’aneddotica, il legame c’è e come e non si può che
apprezzare moltissimo l’idea del Maggio Musicale Fiorentino di rappresentare
finalmente le tre opere insieme. Quella che dunque è forse la più straordinaria
idea drammaturgica del grande maestro lucchese viene finalmente presentata
nella sua interezza in una edizione che parte domani alle 20 e che avrà tre repliche: domenica 17 novembre ore 15:30; e il 20 e 23 novembre ore 20. Si tratta di un Nuovo
allestimento del Teatro del Maggio in
coproduzione con il Teatro
del Giglio di Lucca
e il Teatro
Lirico di Cagliari:
la regia delle tre opere è affidata, insieme alla scenografia, costumi e luci a
Denis Krief, mentre il maestro concertatore e direttore d’orchestra sarà
Valerio Galli (ottima scelta, almeno per quanto ci concerne). Numerosissimi
ovviamente gli interpreti (v. infra) tra cui segnaliamo almeno Bruno de
Simone per il personaggio di Schicchi; tutte le recite sono state dedicate alla memoria del grande Rolando Panerai, storico interprete dello Schicchi, scomparso poche settimane fa.
Il trittico è inserito in una intensa programmazione dedicata dal Maggio a Giacomo Puccini lungo i mesi di novembre e dicembre, con numerosi appuntamenti anche per i più giovani, come previsti i due titoli per i giovanissimi e per le scuole realizzati da Manu Lalli, Ciak! Bohème - una prima assoluta - al Teatro Goldoni a partire da 5 novembre per 9 recite e La stagione dei fiori (i due titoli sono tratti da La bohème) per il terzo ciclo del Maggio Metropolitano.
Il tabarro è un dramma violento che può ricordare una Cavalleria Rusticana ambientata nella Parigi di inizio XX secolo. Il protagonista, Michele, è il proprietario di una chiatta sulla Senna, uomo infelice e rassegnato a una vita di fatiche e privazioni. La giovane moglie di lui, stanca della squallida esistenza offertale dal marito battelliere, intreccia una relazione clandestina con Luigi, uno degli scaricatori che lavora sulla chiatta. Ma Michele è un marito geloso, e una volta scoperta la tresca tra i due, uccide l’amante e lo avvolge nel suo tabarro per gettarlo ai piedi della moglie fedifraga. Il triangolo amoroso marito-moglie-amante che finisce in tragedia è storia nota, qui resa ancor più amara dall’ambientazione desolata e da personaggi dei bassifondi urbani mossi da istinti primari. Puccini li ritrae in musica con grande realismo seguendone come in presa diretta le vicende: la sua scrittura si ammanta di aspre dissonanze e cupi contrasti timbrici, lunghi passaggi in declamato o in arioso che sovrastano il consueto slancio lirico. Una scrittura orchestrale che se sembra per alcuni aspetti “ammiccare”a Cavalleria o a Bohéme, prende la distanza definitiva da quel lo che a torto o a ragione si definisce “verismo” musicale per un linguaggio straordinariamente moderno che spazia da Stravinsky a Ravel e forse addirittura oltre,
Se c’è un punto di forza che le altre due opere hanno rispetto alla prima è sicuramente nel libretto, grazie all’abilità e alla “toscanità” di Giovacchino Forzano, che soprattutto con lo Schicchi riesce a creare il “libretto perfetto”.
Per quanto riguarda Suor Angelica, in una vecchia, commovente intervista filmata, il librettista racconta di come Puccini fosse entusiasta del soggetto. [1] “ Quando si trattava di pensare alla scena di Suor Angelica, io lo condussi a vedere alla chiesetta di Cellole (San Gemignano) che gli piacque moltissimo” . “Per me tutto è indifferente, tutto ciò che non sia Angelica” – ebbe a dichiarare il maestro. Forzano ricorda ancora come per la prima vola Puccini eseguì l’opera al pianoforte nel convento di Vicopelago, davanti alla sorella monaca Iginia e a tutte le altre suore, tra la commozione generale. Come ricorda Alberto Cantù, in suor Angelical’esercizio stilistico e l’angolazione sperimentale muovono da una scelta senza precedenti nel melodramma: un’opera tutta al femminile. Ma non solo per questo. La vicenda di Suor Angelica è questa: a fine Seicento, una giovane suora di nobile costretta a monacarsi a causa di una relazione riceve la visita della algida e scostante zia principessa, per regolare alcune questioni familiari. Qui ella viene a sapere che il bambino nato dalla sua relazione è morto. Disperata, per raggiungerlo si avvelena con delle erbe del giardino del convento; ma presa dal terrore della dannazione, invoca un miracolo e lo ottiene: la Madonna stessa le appare insieme al suo bambino e la povera giovane può morire confortata.
Ma alla vicenda della suora la breve opera, divisa in sette episodi – pannelli, ne riserva solo tre, gli ultimi: la zia principessa, la grazia, il miracolo. Gli altri quattro ( la preghiera, le punizioni, la ricreazione e il ritorno dalla cerca) sono occupati dalla cornice e dall’ambiente: “ sono i piccoli – grandi accadimenti, le bugie dette o sottaciute, gli stupori e le malinconie improvvise e le attese silenziose mentre si prende graduatamente conoscenza del lento fluire del tempo.”[2] Pascoli, purtroppo già scomparso da sei anni quando l’opera, insieme alle altre due “sorelle”, ebbe il suo battesimo nel 1918, avrebbe sicuramente parlato di “sentore d’innocenza e di mistero”. E c’è molto di Pascoli, che di Puccini fu grande estimatore, in quest’opera di grande fascino e grande ardimento teatrale e musicale: una sfida degna di Ravel.
S’apre la scena col morto in casa. \ Tutt’i parenti borbottan preci, \ viene quel Gianni-tabula rasa: \ fiorini d’oro diventan ceci. Così, con questi cinici e irriverenti versi Giacomo Puccini commentò la vicenda di Gianni Schicchi che Giovacchino Forzano gli aveva ricavato nientemeno che da un passo dell’Inferno di Dante, o più precisamente dal commento dell’Anonimo Fiorentino del XIV secolo.
Opera comica? Opera sarcastica, di un umorismo acre, “cattivo” , toscano, ebbe un successo e una popolarità ben superiore a quella delle due “sorelle”; ma non senza riserve da parte della critica. Leonardo Pinzauti, che pur ne apprezzava “l’uso geniale delle più raffinate risorse del linguaggio timbrico” ne lamenta “ certo suo ‘fiorentinismo’ da strapaese (imputabile prima di tutto al libretto di Forzano), con inserti musicali, falsamente popolareschi, che di fatto rompono la preziosa unità stilistica dell’opera”. Viceversa Enzo Siciliano elogia (giustamente) il libretto, ma “Il gioco di marionette che è lo Schicchi, troppo magro e così avaro di più sostanziosi motivi, lascia freddi: fredda è la sua concezione”. Giudizi francamente assai poco o meglio per nulla condivisibili, con tutto il rispetto per gli illustri critici in questione.
La trama parte per l’appunto d un episodio del XXX canto dell’Infernodi Dante (falsari);
Quel folletto è Gianni Schicchi, /e va rabbioso altrui così conciando (…)
per guadagnar la donna de la torma,/falsificare in sé Buoso Donati/testando e dando al testamento norma.
Notazione tanto scarna quanto efficace, che però viene chiarita e approfondita dal commento dell’Anonimo Fiorentino, che Forzano seguì abbastanza fedelmente, costruendo uno dei libretti più belli ed “efficaci” del primo Novecento (e non solo) inventando i personaggi dei parenti avidi e interessati (chi l’avrebbe mai detto che quando Buoso andava al cimitero, si sarebbe pianto per davvero! cantano sconsolati quando si scoprono diseredati) , mentre l’anonimo parla solo di un “figliolo”:
Firenze, Anno Domini 1299. I parenti del ricco Buoso Donati fingono ipocritamente di piangerne la dipartita (rappresentata dalle stesse prime battute dell’orchestra, a cui segue immediatamente il tema del” finto pianto”) ma in realtà sono interessati solo al testamento, soprattutto perché “dicono a Signa” che l’erede sia …. Un convento di frati (Se Buoso crepa, pei frati è manna; diranno pancia mia fatti capanna!) La ricerca del testamento rivela che le cose stanno davvero così ma il giovane Rinuccio propone di rivolgersi all’astuto Gianni Schicchi, padre di Lauretta di cui è innamorato. Questi, esponente della “gente nova” detesta i Donati che lo snobbano; ma convocato da Rinuccio si reca da loro con la figlia. I Donati, soprattutto Zita la Vecchia, lo accolgono con sdegno e lui li manderebbe volentieri al diavolo , ma per l’intervento della figlia (con l’aria più celebre, O mio babbino caro) decide alla fine di aiutarli. L’ispirazione gli viene dalla visita del medico, il borioso e ridicolo maestro Spinelloccio; imitando la voce di Buoso gli fa credere che questi è vivo e che sta meglio. Ma se ha ingannato così facilmente il medico, potrà farlo anche con il notaio, e dettare dunque un nuovo testamento. E così accade, ma ….
La trama è sicuramente molto nota ma lasciamo a chi ignora il finale il piacere della sorpresa. Così come una sorpresa è questa partitura ricca di invenzioni e “novità” novecentesche, godibilissima nella sua complessità e nella sua … perfidia.
Infine, un’ultima nota per la regia, per la quale lasciamo la parola direttamente a Denis Krief: “ Decidere per una scenografia che potesse essere idonea ai tre titoli non era semplice, e a rendere le cose più complicate ancora sono le differenti architetture dei teatri in cui sono rappresentate le tre opere! Aggiungiamo a questo le finanze sempre più risicate delle nostre fondazioni liriche.
Mi sono deciso per una scenografia apparentemente semplice, unica per le tre opere. In fondo è meglio così: il significato delle cose che vediamo in scena viene dato dalla storia e dalle situazioni drammatiche che raccontiamo, mentre la scenografia accompagna la narrazione registica.
Tocchi di realismo vengono dati da attrezzi usati nell’azione scenica. Così, la dimensione simbolica delle varie funzioni sceniche rimane intatta e non alterata da decorativismo o abusi. I costumi seguono la stessa logica, anche se sono molto diversi visti i tre soggetti: realismo sociale nel mondo degli scaricatori di porto, naviganti, barboni e poetiche puttane notturne ne Il tabarro; suore in bianco (siamo nel periodo della Quindena dedicato a Maria) per Suor Angelica e infine una famiglia provinciale borghese che si lacera per un’eredità in Gianni Schicchi.
Come spesso faccio, non cerco in nessun modo di fissare un’epoca con i costumi: sarà cura della musica o del dramma di suggerirla qualora fosse necessaria. Lascio al costume la sua funzione sociale, così che caratterizzi, passando da un titolo all’altro, il milieu o la categoria sociale alla quale appartiene il personaggio e in cui si svolge l’azione.”
Artisti
IL TABARRO
Opera in un atto (da La Houppelande di Didier Gold)
Libretto di Giuseppe Adami
Musica di Giacomo Puccini
Editore Casa Ricordi, Milano
Nuovo allestimento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
in coproduzione con il Teatro del Giglio di Lucca
e il Teatro Lirico di Cagliari
Maestro concertatore e direttore Valerio Galli
Regia Denis Krief
Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino
Maestro del Coro Lorenzo Fratini
Michele Franco Vassallo
Luigi Angelo Villari
Il “Tinca” Antonio Garés*
Il “Talpa” Eugenio Di Lieto
Giorgetta Maria José Siri
La Frugola Anna Maria Chiuri
Un venditore di canzonette Dave Monaco *
Due voci interne Thalida Fogarasi**, Leonardo Sgroi**
Due amanti Costanza Fontana*, Claudio Zazzaro*
Midinettes Maria Cristina Bisogni**, Cristina Pagliai**, Sarina Rausa**, Elena Bazzo**, Elisabetta Ermini**, Delia Palmieri**
Figurante speciale Fabrizio Casagrande
Allestimento Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Scene e attrezzeria Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Costumi Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
SUOR ANGELICA
Opera in un atto di Giovacchino Forzano
Musica di Giacomo Puccini
Editore Casa Ricordi, Milano
Nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari
in coproduzione con il Teatro del Giglio di Lucca
e il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Maestro concertatore e direttore Valerio Galli
Regia Denis Krief
Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino
Maestro del Coro Lorenzo Fratini
Suor Angelica Maria José Siri
La Zia Principessa Anna Maria Chiuri
La Badessa Marina Ogii
La Suora Zelatrice Anna Malavasi
La Maestra delle Novizie Giada Frasconi*
Suor Genovieffa Costanza Fontana*
Suor Osmina Elena Cavini*
Suor Dolcina Nikoleta Kapetanidou*
La Suora Infermiera Carmen Buendia*
Prima Sorella Cercatrice Eunsong Lim
Seconda Sorella Cercatrice Francesca Longari*
Prima Conversa Marilena Ruta*
Seconda Conversa Emma Alessi Innocenti
Prima Novizia Marta Pluda*
Seconda Novizia Julia Costa*
Tre suore Daniela Losi**, Consuelo Cellai**, Amanda Ferri**
Allestimento Teatro Lirico di Cagliari
Scene, costumi e attrezzeria Teatro Lirico di Cagliari
GIANNI SCHICCHI
Opera in un atto di Giovacchino Forzano
Musica di Giacomo Puccini
Editore Casa Ricordi, Milano
Nuovo allestimento del Teatro del Giglio di Lucca
in coproduzione con il Teatro Lirico di Cagliari
e il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Maestro concertatore e direttore Valerio Galli
Regia Denis Krief
Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino
Maestro del Coro Lorenzo Fratini
Gianni Schicchi Bruno de Simone
Lauretta Francesca Longari*
Zita detta La Vecchia Anna Maria Chiuri
Rinuccio Dave Monaco*
Gherardo Antonio Garés*
Nella Costanza Fontana*
Gherardino Matteo Lantieri
Betto di Signa Francesco Venuti*
Simone Eugenio Di Lieto
Marco Min Kim*
La Ciesca Giada Frasconi*
Maestro Spinelloccio Enrico Marabelli
Ser Amantio di Nicolao Enrico Marabelli
Pinellino Shuxin Li*
Guccio Adam Jon
Figurante speciale Fabrizio Casagrande
Allestimento Teatro del Giglio di Lucca
Scene, costumi e attrezzeria Teatro del Giglio di Lucca
*artisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino
**artisti del Coro del Maggio Musicale Fiorentino
[2] Alberto CANTU’, L’universo di Puccini da le Villi a Turandot, Varese, Zecchini editore, 2008, pp. 178-179.
Piaciuto questo Articolo? Condividilo...
Cultura
DER IUNGE LORD: un trionfo meritato. L'opera di Henze stupisce e incanta il pubblico fiorentino
La grande musica russa: Daniele Gatti incanta il pubblico fiorentino con Stravinsky e Prokof'ev
SALOME: un grande inizio per l'87° festival
Grande diva: Jessica Pratt incanta con Norma. Uno spettacolo di alto livello trionfa al Maggio Musicale
RIGOLETTO: trionfo del capolavoro verdiano al teatro del Maggio
Teatro
DER IUNGE LORD: un trionfo meritato. L'opera di Henze stupisce e incanta il pubblico fiorentino
SALOME: un grande inizio per l'87° festival
Grande diva: Jessica Pratt incanta con Norma. Uno spettacolo di alto livello trionfa al Maggio Musicale
RIGOLETTO: trionfo del capolavoro verdiano al teatro del Maggio
Sorrisi e risate amare. Due opere in un atto molto particolari in arrivo al Maggio: Mavra e Gianni Schicchi
In Poltronissima da...
DER IUNGE LORD: un trionfo meritato. L'opera di Henze stupisce e incanta il pubblico fiorentino
SALOME: un grande inizio per l'87° festival
Grande diva: Jessica Pratt incanta con Norma. Uno spettacolo di alto livello trionfa al Maggio Musicale
RIGOLETTO: trionfo del capolavoro verdiano al teatro del Maggio
Sorrisi e risate amare. Due opere in un atto molto particolari in arrivo al Maggio: Mavra e Gianni Schicchi