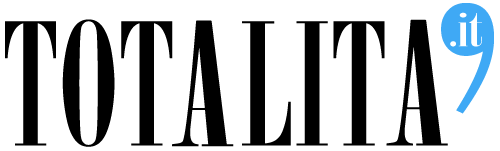Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.

27 luglio 1452
Ludovico il Moro, Storico nobile italiano
Sempre alla ricerca di alleanze per conservarsi al vertice del Ducato, L. concluse le nozze tra Bianca Maria Sforza (sorella del duca e nipote di L.) e Massimiliano d'Asburgo
di Totalità

LUDOVICO (Ludovico Maria) Sforza, detto il Moro, duca di Milano. -
Nacque a Milano, nel palazzo dell'Arengo, nel 1452 (e non nel 1451 come data
Bernardino Corio), il 3 agosto (e non nel castello di Vigevano il 27 luglio),
quarto di sei figli maschi del duca di Milano Francesco e di Bianca Maria
Visconti. Rimettendosi, per il nome, alla scelta della consorte, il padre
raccomandava che si chiamasse anche "Charles": "Charles nostro
figliuolo", si riferiva in effetti al neonato. Ma la preferenza onomastica
non attecchì, anche se di "Carles" e "Carolus" restò
qualche traccia cronachistica; invece il nome valido fu quello di Ludovico
seguito da Maria (come già per i fratelli maggiori Galeazzo, Filippo, Sforza e
come sarà per il minore Ascanio), secondo la volontà della madre particolarmente
devota alla Vergine, e quello ufficiale pertanto, usato nelle carte pubbliche,
nella diplomazia, nelle monete, negli Statuta civilia - editi a
Milano nel 1498 - reformata, appunto, da Ludovico Maria Sfortia.
"Lodovicus Maria vice comes" si firmava L. quindicenne.
Scuro di carnagione, nero d'occhi e capelli, il padre amava chiamarlo "Maurum" (e "Lodovicus Maurus" risulta già in un documento del 1461) e con l'andar del tempo fu dunque "cognominato il Moro". L'appellativo non gli dispiacque se, a sottolineare l'apparenza d'"homo niger", sarebbe comparso accompagnato da uno scudiero nero e, sempre di proposito, avrebbe protetto l'impresa del gelso - "moro" in Lombardia -, la pianta latrice della fiorente produzione della seta e, insieme, figurazione allusiva alla "sophia" con la quale, "Morus agnomen", egli governava.
In pericolo di vita sui cinque anni, L. crebbe poi irrobustito fisicamente e desto mentalmente. A Mantova nel 1459 accolse, con la madre e i fratelli, il papa Pio II; il 25 dic. 1463 dette prova dei progressi nelle "lettere", recitando ai genitori una orazioncella edificante composta di proprio pugno in latino. Nutriva anche una grande passione per la caccia, che praticava assiduamente pur senza trascurare lo studio; e ad attestare l'abilità venatoria, nel novembre 1464, inviò al padre un grosso cervo da lui saettato. Francesco Sforza, il 2 giugno precedente, gli aveva affidato il comando nominale di 2000 cavalli e di 1000 fanti, da guidare nell'"imprexa del Turco": capitano per finta il fanciullo, tanto per simulare una cortese attenzione alla crociata vagheggiata dal pontefice.
Ma, morto il padre l'8 marzo 1466 e succeduto il primogenito Galeazzo Maria, iniziarono per L. autentiche responsabilità, allorché fu inviato a Cremona (dove arrivò il 18 insieme con il commissario Tommaso Tebaldi) a incoraggiare, con la sua presenza in castello, il lealismo degli abitanti e a prestare attenzione ai servizi di sorveglianza per la "guardia de questa terra". Continuava, intanto, ad applicarsi agli studi, seguito da Matteo Avellani e da Franchino Caimi. Nel settembre 1466, lo colpì la "febre terzana", da cui si riprese grazie alle cure del medico ducale Guido Perati; il 2 novembre altri due medici, Giacomo da Gallarate e Filippo da Novara, assicuravano che il ragazzo era oramai "de bona voglia", giocava "a triomphi", si portava alla stalla a vedere "li cavalli soy". Dopo un soggiorno a Milano, L. fu rimandato a Cremona, donde, il 20 maggio 1467, scriveva alla madre che era scrupoloso nell'"oldire la messa" e pure il "vespero". La situazione a Cremona era tranquilla. Eppure il 10 maggio Bartolomeo Colleoni aveva oltrepassato il Po. Spettava a Galeazzo Maria affrontare quel "turbatore et inimico de la pace italica"; e L., il 25, augurò al fratello un trionfo militare donde il condottiero bergamasco sortisse "confuso et fracassato".
Fisso a Cremona sino all'autunno inoltrato, quindi a Genova a incontrare la sorella Ippolita, moglie di Alfonso d'Aragona, a fine anno L. giunse a Milano, dove, il 30 genn. 1468, fu proclamato che il duca, se assente, fosse sostituito nelle udienze "alternativamente" da Sforza Maria, duca di Bari, e da L., fresco del titolo di "conte de Mortara". Il 6 giugno L. era a Genova ad attendervi fino al 26 Bona di Savoia, la sposa di Galeazzo Maria che poi scortò a Milano, dove il 7 luglio ebbero luogo le nozze. Alla cerimonia, così come alle esequie della madre, morta il 23 ottobre, L. apparve ancora figura di secondo piano. Sebbene, nel marzo del 1470, sembrò che il duca volesse inviarlo in Francia, a capo di "uomini d'armi 100, cavalli 600, squadre 4", e in luglio "in Bolognese", di fatto, L. ebbe incarichi di mera rappresentanza senza potere nutrire grandi ambizioni.
In agosto, a Novara, accolse un'ambasciata francese; nel gennaio 1471, a Venezia, omaggiò la Repubblica; in agosto, a Roma, si genuflesse con il neopontefice Sisto IV; in settembre si portò a Torino "incontro a la duchessa", sua cognata. In marzo a Genova L. apparve - nella cerimonia di "riverentia" - alla destra del fratello duca, ma "terzo" dopo Filippo Maria e Sforza Maria, e i diplomatici lo designarono come "illustre messer" o "illustre domino".
Inviato in Francia, più per vedere il mondo che con un compito preciso (e infatti, giunto a Tours il 21 dic. 1476, il re lo ricevette solo il 25), L. apprese sulla via del ritorno la notizia dell'assassinio di Galeazzo Maria, avvenuto il 26 dicembre. Il 28 genn. 1477 prestò giuramento di fedeltà al nuovo governo, guidato da Bona Sforza come reggente per il piccolo Gian Galeazzo Maria e dal consigliere Cicco Simonetta, e partecipò alla spedizione che l'11 aprile domò la ribellione di Genova. Ma L. non si adattò a rimanere in subordine, confinato nel Consiglio di giustizia, e il 25 maggio ordì una congiura, cui presero parte tutti i fratelli del duca defunto, a eccezione di Filippo Maria (uomo senza ambizioni politiche, al punto di rinunciare al titolo di conte di Corsica il 13 genn. 1472). Il tentativo fallì e, mentre il giovane Ottaviano annegava nell'Adda durante la fuga, gli altri furono esiliati: Sforza Maria nel suo Ducato di Bari; Ascanio Maria a Perugia; L. a Pisa.
Costretto a una forzata inattività, L. avvertiva il "perdersi la sua zoventude"; la sola "recreatione" era quella della caccia, per la quale il duca Ercole I d'Este gli mandò uno dei migliori falconi di cui disponesse, suggerendogli nel contempo di avere "gran paciencia e sumesione" con la duchessa, consigliata alla fermezza dal Simonetta, e di non pretendere, con i suoi reiterati appelli, che gli venisse concesso il rientro a Milano.
Nell'agitazione successiva alla congiura dei Pazzi (26 apr. 1478) - quella per cui il pontefice e il re di Napoli si attivarono contro la Firenze medicea appoggiata da Milano -, si offrì a L. l'opportunità di sottrarsi all'immobilità pisana. Ferdinando I d'Aragona fornì a lui e al fratello Sforza Maria i mezzi per intervenire. L. "ha rotto le confine et è venuto a Pietrasanta", scriveva da Milano, il 27 genn. 1479, l'oratore mantovano. Unitosi a La Spezia con il fratello e Roberto Sanseverino, L. procedette devastando il Genovesato e parte del litorale toscano nell'intento di entrare in Lombardia. Il 22 febbraio i due fratelli furono proclamati "per ribelli": il Simonetta e la reggente, concordi, impedivano loro il ritorno, mentre essi si dichiararono determinati a "entrare in casa" a difendere il "duca piccinino" - Gian Galeazzo Maria - liberandolo "dalla tirannia di Cicco", di cui la stessa madre sarebbe stata vittima. L. e Sforza Maria, comunque, non disponevano di forze adeguate; i contributi aragonesi erano troppo scarsi per il pagamento delle truppe e lo stillicidio delle diserzioni si fece quotidiano: non pagati, "li fanti [(] se li fugono". Per giunta, il 27 luglio 1479, a Varese Ligure, morì Sforza Maria, da tempo malato. Il 14 agosto Ferdinando I concesse a L. il Ducato di Bari, di cui il fratello defunto era stato titolare, sicché egli acquisì Bari, Palo, Modugno con i relativi diritti e redditi, in particolare quelli della dogana del sale e dei fuochi.
L'iniziativa militare si rianimò: il 20 agosto le truppe capeggiate dal Sanseverino e da L. mossero da Varese Ligure e, "per la val Sturla" e la "val Baviera", il 23 presero Tortona. "Tutte le terre di là da Po" furono conquistate - constatava l'inviato gonzaghesco -, dunque Sale, Castelnuovo Scrivia, Bisignano e Valenza, inclusa la rocca ceduta dal castellano. Da questa posizione di forza, L. trattò con la reggente. Il 7 sett. 1479, munito di un salvacondotto e scortato "con quattro cavalli solamente", entrò a Milano a "rimettersi liberamente ne la mano" della cognata. Era un ritorno remissivo solo in apparenza, perché sconfessava la linea di fermezza sostenuta dal Simonetta, ma non solo: già l'indomani fu evidente che la reggente era intenzionata a "liberamente" concedere al cognato piena autorità e ad abbandonare il Simonetta, di cui il 10 infatti L. ordinò la detenzione "in una camera di castello". Seguì una vera e propria "mutatione di governo" a esclusivo vantaggio di L., mentre risultarono delusi il Sanseverino nella sua pretesa al titolo di "locotenente" e pure Ascanio Maria, che fu risarcito con la porpora cardinalizia solo il 17 marzo 1484. Gli stessi "ghibellini", già determinati, specie con Pietro Pusterla, a favorire il rientro di L., ben presto furono "malissimo contenti" di lui.
Il comando era saldo nelle mani di L. "governatore", e rafforzato nell'ottobre 1480 dall'allontanamento dalla corte di Antonio Tassino, l'amante della cognata, che pure si era adoperato per separarla dal Simonetta, decapitato il 30 ottobre. Il 3 novembre, il Consiglio ducale affidò a L. la tutela del nipote Gian Galeazzo Maria, esautorando la madre, ridotta a pensionata di lusso ad Abbiategrasso. A quel punto, secondo il lapidario giudizio di Lorenzo de' Medici, L. "non solamente ha il governo di codesto stato nelle mani, ma tutte le cose d'Italia".
Riconfermato l'impegno nuziale sforzesco-aragonese dei cugini Gian Galeazzo Maria e Isabella d'Aragona, entrambi nipoti di L., egli nel 1482 appoggiò le operazioni aragonesi in occasione della guerra di Ferrara e svolse un ruolo determinante nello stesso accordo veneto-estense della pace di Bagnolo il 7 ag. 1484. Il sostegno dato da L. a Ferdinando I contro la congiura dei baroni fu premiato con il conferimento dell'Ordine dell'Armellino, nel novembre 1486. Nel 1487, le truppe milanesi respinsero gli Svizzeri giunti sino a Domodossola e in luglio recuperarono Genova, sottrattasi nel 1479 al dominio sforzesco. Ma, nel 1488, L. fu costretto a riconoscere la sovranità della Francia sulla città; e risultò altresì vano lo sforzo di contrastare l'influenza francese nel Ducato sabaudo e nei Marchesati di Monferrato e di Saluzzo. Invece fu efficace, per sventare le mire fiorentine su Forlì, il cui signore Girolamo Riario era stato assassinato il 14 apr. 1488, l'aiuto prestato da L. alla vedova, l'energica Caterina Sforza, che, in quanto figlia naturale di Galeazzo Maria, gli era nipote.
Il matrimonio tra Gian Galeazzo Maria e Isabella d'Aragona, siglato per procura il 21 dicembre e solennizzato a Milano nel febbraio 1489, sembrò sigillare la sinergia milanese-napoletana. Ma proprio in questa unione si nascondevano i germi dei futuri dissapori: l'incontro, il 25 genn. 1489, fu funestato dalla mancata consumazione del 28. L'inadempienza del nipote suscitò la malcelata soddisfazione di L., che derise il giovane, dando prova di scarso gradimento per il successivo funzionamento del matrimonio, allietato il 30 genn. 1491 dalla nascita di Francesco, l'erede. Malgrado ciò, L. era determinato a continuare a essere "solo e vero principe di Milano". Gian Galeazzo Maria - debole fisicamente e di indole neghittoso - subiva il protagonismo dello zio, mentre Isabella non mancò di protestare con il nonno Ferdinando I e con il padre Alfonso d'Aragona, sicché L. apparve usurpatore fedifrago agli occhi della corte napoletana, dove a metterlo vieppiù in cattiva luce concorse Gian Galeazzo Trivulzio. I due si odiavano, appellandosi l'un altro sprezzantemente "Lodovico da Cotignola", luogo d'origine degli Sforza, e "Giacomo mugnaio".
Si stringevano intanto i legami con gli Estensi: il 17 genn. 1491, nella cappella ducale di Pavia, L. sposò la sedicenne Beatrice, figlia d'Ercole I, sorella di Isabella e di Alfonso, il futuro duca di Ferrara; e questi, il 23, sposò Anna Sforza, nipote di L. e sorella di Gian Galeazzo Maria. Dalla moglie L. ebbe due figli: il 25 genn. 1493 Massimiliano e il 4 febbr. 1495 Francesco. Intanto il permanere "in administratione et gubernio" del Ducato, senza che si prevedesse una scadenza, suonava sempre più arbitrario e sfidava l'inimicizia aragonese. A difesa preventiva sortirono, il 24 genn. 1492, la lega di L. con il re di Francia Carlo VIII - che sul Regno di Napoli accampava pretese - e, il 25 apr. 1493, l'alleanza, questa pure con finalità antiaragonesi, con la Repubblica di Venezia e con Alessandro VI, eletto papa l'11 ag. 1492 anche grazie all'impegno del cardinale Sforza, il fratello di Ludovico.
Sempre alla ricerca di alleanze per conservarsi al vertice del Ducato, L. concluse le nozze tra Bianca Maria Sforza (sorella del duca e nipote di L.) e Massimiliano d'Asburgo, il "re dei Romani", celebrate per procura nel duomo milanese il 30 nov. 1493 e poi, presente la coppia, a Innsbruck il 16 marzo 1494. La dote della sposa era strepitosa (500.000 ducati a calcolare anche i doni); ma L. ottenne il riconoscimento cesareo del Ducato, già richiesto a suo tempo dal padre Francesco, promesso il 24 giugno e accordato il 5 settembre con un'investitura espressamente personale che egli al momento non palesò.
Con la morte di Lorenzo il Magnifico, l'11 apr. 1492, e la calata di Carlo VIII ebbe inizio - secondo il giudizio del Guicciardini destinato a imporsi come communis opinio - la catastrofe che alla penisola arrecò la perdita della "felicità". E, con l'irruzione delle "genti barbaresche", fu minacciato lo stesso Ducato sforzesco, strutturalmente fragile e precario in un'Italia avviata a trovarsi "corsa", "predata", "sforzata", "vituperata".
"Primo motor" di tanto disastro, agli occhi della storiografia soprattutto fiorentina, apparve L., ancorché la cecità e l'insipienza non siano state una sua esclusiva prerogativa, addebitabili come sono anche al pontefice, all'Aragona, alla stessa sapienza civile della Repubblica di Venezia, tutti impaniati in un'atmosfera torbida e confusa, tutti corresponsabili in una gara di astuzie, ripicche, tranelli, voltafaccia nella quale ognuno si proclamava preoccupato del "reposso de Italia", accusando l'altro di turbarlo. Anno infelicissimo il 1494, che "aperse le porte alle infinite calamità" della penisola - secondo lo storico cinquecentesco di Cremona, il pittore Antonio Campi - "per la venuta dei Francesi chiamati" da L.; un'imputazione ribadita da Giuseppe Ripamonti, lo storico seicentesco di Milano; nemmeno il Corio - che pur ritiene L. "glorioso principe" - tentò di scusarlo: "existimato l'arbitro" della penisola - quasi trasferendo a L. il ruolo già del Magnifico -, purtroppo con "reo e pessimo consiglio" si era rivolto alla Francia. Per questa mossa, rivelatasi controproducente anche per lui, L. nutrì sensi di colpa, ammettendo, il 7 sett. 1496, con l'oratore veneto Francesco Foscari di avere "fatto gran male all'Italia" con l'appello a Carlo VIII, pur nella legittima esigenza di autoconservarsi nel "loco". Il colpevole primo, allora, sarebbe stato Ferdinando I che da detto "loco" voleva scalzarlo, un'intenzione pagata cara se - come annota il cronista ferrarese Bernardino Zambotti -, il 25 genn. 1494, moriva "de melanconia" indotta dall'angoscia per l'imminente venuta del re di Francia.
Carlo VIII giunse a Susa il 3 settembre, il 9 ad Asti, dove incontrò L., e il 14 ottobre visitò a Pavia il malandatissimo Gian Galeazzo Maria. Questi morì il 20 dello stesso mese: insofferente della severa disciplina di vita prescrittagli dai medici, non si era voluto curare e, smodato nel bere e nel mangiare, non aveva retto agli eccessi e agli strapazzi. Ma l'"opinion comune", raccolta dall'annalista veneto Domenico Malipiero, volle che la fine del giovane fosse stata procurata dal "tosegho" fattogli propinare da L. "so zio", ciò di cui si convinsero anche Giorgio Valla, il Machiavelli e il Guicciardini.
Erede diretto del titolo ducale era il piccolo Francesco, che non aveva ancora quattro anni, ma questa volta L. non si accontentò di assumere la tutela del "duchetto" e di operare come reggente. Già "duca di Bari, governatore luogotenente e capitano generale ducale", e, nelle iscrizioni delle monete, "Ludovicus patruus gubernans" o "Ludovico patruo gubernante", ritenne giunto il tempo di essere duca a pieno titolo. La proposta di Antonio Landriani di proclamare L., in grado di esibire l'investitura cesarea per sé e i propri discendenti, fu accolta all'unanimità dai consiglieri locali e il 22 "lo intero governo dello Stato" gli spettò anche di diritto: dux, da quel momento, l'appellativo nelle acclamazioni del popolo, nelle diciture delle monete. L. - annotava sconcertato Philippe de Commynes - si è "eletto da solo", mettendo "tutti nel sacco", un'operazione di successo nella quale il poeta cortigiano Bernardo Bellincioni avvertiva astuzia di volpe, energia di leone, rapacità di falco. L'esordio con la titolarità di duca fu enfatizzato da gesti di magnanima benevolenza, secondo consuetudine: la concessione del taglio dei boschi nelle terre riservate alle sue cacce; la restituzione di alcune di esse; la soppressione di gabelle e l'abolizione del dazio sulle biade.
Saldamente insediato, L. prestò a Carlo VIII 200.000 ducati, perché non svernasse "in casa" sua. Si affiancò al procedere della spedizione; ma già il 6 novembre lasciava il campo francese in Toscana, per tornarsene a Milano, "coll'animo turbato contro a Carlo", furente per il rifiuto di questo di "lasciare a guardia sua" Pietrasanta e Sarzana.
Il re di Francia entrò a Firenze il 17 novembre e a Roma il 1( genn. 1495, ma dal 13 dicembre le truppe di L. erano state richiamate: egli aveva assunto una posizione defilata. Pertanto, nella corte ducale non si parlava più "male" del re di Napoli Alfonso d'Aragona, anzi L. provava sin "grande compassione" per lui e lo auspicava "victorioso" - informava da Milano l'inviato gonzaghesco - e, nel contempo, i "Franzesi" non erano più tenuti "in excelsis" e "molto refredita la inteligentia" con Carlo VIII, sebbene questi il 22 febbr. 1495 indirizzasse a L. una lettera da Napoli, dove era entrato, nella quale - riassumeva il mantovano Benedetto Capilupi - "recognosceva gran parte di questa victoria", proprio al sostegno venutogli dalla "iusticia" e "prudenza" di Ludovico. Ma egli (ora "più aragonese che ingiuino") e i veneziani "non pensano ad altro che in expellere el re de Franza de Italia" - ragguagliava il 3 marzo il Capilupi - e, a tale scopo, stipularono il 31 la Lega antifrancese detta santa, a cui aderirono anche il papa, la Spagna e l'Impero. L'impegno militare profuso da L. il 5-6 luglio a Fornovo fu modesto, tuttavia; e la conquista di Novara il 13 giugno da parte del duca Luigi d'Orléans (che avanzava pretese su Milano, legittimate con il proprio discendere da Valentina Visconti) costituì una bruciante umiliazione senza che L., tuttavia, si proponesse di riconquistarla con le armi in pugno. Solo con la pace separata siglata a Vercelli il 9 ottobre, L. riottenne Novara, e pure Genova, in cambio della disponibilità di navi genovesi per Carlo VIII.
A L. parve di avere la fortuna dalla sua: celebrato dai letterati cortigiani come "figlio della fortuna", il prestigio cresceva con i successi ed egli ne insuperbiva, quasi potesse - ironizza il Malipiero - disporre del papa come cappellano, di Massimiliano d'Asburgo come uomo d'armi, della Serenissima quale tesoriere, dello stesso re di Francia quale corriere postale. È certo che - nell'ininfluenza di Firenze e di Napoli - il peso relativo di Milano lievitava e risaltava l'eminenza di L., pronto a illudersi protagonista e arbitro delle sorti della penisola. Sostenne la ribellione di Pisa a Firenze; poi, con un brusco voltafaccia, costrinse Genova a interrompere i soccorsi a quella, giudicando più conveniente, per la tutela del versante orientale del Ducato, che la Serenissima rimanesse impegnata nel conflitto con Firenze.
Proprio mentre assaporava la pienezza del potere, L. fu colpito duramente negli affetti per la morte, il 22 nov. 1496, dell'amatissima figlia naturale Bianca (frutto della relazione con un'avvenente popolana di Bari), adolescente sposa di Galeazzo Sanseverino, e poi, il 3 genn. 1497, della moglie Beatrice e del neonato maschio, partorito solo poche ore prima. La corte ducale, già festevolmente mondana, già "lieto paradiso", si tramutò - annota Vincenzo Collio (detto il Calmeta) - "in tenebroso inferno". La perdita della consorte - "la più cara cossa havessimo a questo mondo", scrisse L. alla cognata Isabella d'Este - costituì una sofferenza della quale non sapeva darsi pace, nonostante fosse uomo dai molti amori, taluni palesi, altri furtivi (e dai numerosi figli naturali). E, a identificarsi nel lutto insopportabile, quasi ad autorappresentarsi quale vedovo definitivamente inconsolabile, impose il colore che da sempre lo qualificava: vestiva "de negro", fece "vestire tutti li suoi ragazzi de veluto negro", pretendeva perfino, negli spostamenti, "alloggiamento [(] tutto negro"; mentre, ad attenuare lo strazio, si dava "ogni dì più ne la devotione", prediligendo il "monasterio de le Gratie", per il quale fece "fare una grandissima spesa". Proprio a questi sentimenti di "devozione", e non solo a criteri di esclusiva ragione politica, sono riconducibili taluni interventi legislativi in materia beneficiale, quale l'adozione, nel 1497, di un nuovo metodo nella scelta dei candidati ai benefici e l'abolizione, il 23 genn. 1498, dei decreti contro la libertà ecclesiastica.
Morto, il 7 apr. 1498, Carlo VIII, gli successe Luigi XII, il quale - come scrive, il 28, l'oratore mantovano Donato Preti - era "molto disposto et inclinato" all'"impresa de Italia" per tentare "il titolo del ducato de Millano, del qual al continuo se ha per il passato intitulato". L. si ritrovò, dunque, diretto bersaglio del nuovo re.
Purtroppo Massimiliano d'Asburgo - le cui operazioni antisvizzere finanziate da L. non ebbero buon esito - non fu in grado di mobilitarsi a fronteggiare Luigi XII, che contava sul papa e la Serenissima come alleati, mentre L. non aveva dalla sua che Napoli. Per tenere "in brilia" Venezia, L. - deposto ogni scrupolo devoto - non esitò a fare appello al Turco e, per tramite di inviati a Costantinopoli, fece capire di essere disposto, in cambio di un valido aiuto, a sposare una figlia del sultano Bajazet II. Mentre L. restava privo di sostegno, in agosto i Francesi procedettero inarrestati, prendendo Voghera e Tortona, e capitolò Alessandria, dove si era concentrata la resistenza. Il 25-26, poi, le truppe veneziane varcarono l'Oglio, occupando la Ghiara d'Adda, Caravaggio, Soncino. Franava - secondo il diarista veneziano Girolamo Priuli - la "caxa sforzesca", già "in grandissima felicitade", già "la più famosa [(] de la Italya et la più regnante". L. fece ricorso ancora alla mobilitazione generale, malgrado si gridasse "Francia, Francia"; ma poi - dopo avere rinunciato il 31 agosto al Ducato di Bari in favore d'Isabella d'Aragona, la vedova di Gian Galeazzo Maria - si decise alla fuga con Galeazzo Sanseverino, il vedovo della figlia Bianca, e Gaspare Sanseverino d'Aragona, detto il Fracasso, il 2 settembre. Il 6 i Francesi, capeggiati dall'odiato Trivulzio, entrarono a Milano, e qui, dopo la capitolazione del castello il 17, Luigi XII fece il suo ingresso trionfale, il 6 ottobre, lasciando nondimeno la città il 9 novembre, forte anche della sottomissione di Genova avvenuta il 26 ottobre. Intanto L., riparato sotto la protezione asburgica, passò a Bolzano, poi a Innsbruck, quindi a Bressanone e, con il favore di Massimiliano, organizzò il recupero del Ducato. I "populi", già malcontenti di L. "tiranno", erano stati in breve delusi dal luogotenente Trivulzio, spadroneggiante e vessatorio con smaccato favoritismo per la fazione guelfa. All'apparire di L. al comando di truppe svizzere e borgognone, le scarse forze degli occupanti lasciarono Milano, il 3 febbr. 1500, per attestarsi il 4 a Novara, mentre il 6 L. rientrava a Milano. Iniziò la ripresa - sebbene Venezia occupasse Lodi e Treviglio - e il 22 marzo Novara fu riconquistata. Ma a Vercelli, intanto, arrivò a rinforzare il nemico l'armata guidata da Louis de la Tremoille: il 5 aprile ebbe inizio lo scontro, nel corso del quale le truppe di L., dapprima animose, l'8 e il 9 desistettero segnando la sconfitta del loro signore. Agli Svizzeri fu concesso il salvacondotto per arrivare a Bellinzona e L. tentò di evitare la cattura, mescolandosi, camuffato, a essi. Fu riconosciuto e arrestato il 10, l'11 rinchiuso nel castello di Novara, mentre il 14 l'avanguardia dell'esercito francese entrò a Milano.
Si concluse così, con la destinazione a essere "in Francia misero et captivo", la personale avventura di un uomo che - a detta di Cosimo Bartoli -, se era stato "quasi sempre infedele", fu ripagato con la stessa moneta dalla Francia, dalla Serenissima, dagli stessi suoi sudditi, i quali, appunto, "li mancarono della fede". Quanto alla sconfitta, il Campanella, memore di Machiavelli, l'attribuirà all'"abondanza di soldati mercenari ed ausiliari e difetto di propri". Per Marino Sanuto, invece, responsabile del malanimo dei sudditi per il governo di L., fu l'eccessivo fiscalismo: l'"extrusion" di denari ai "so populi". In effetti, L. operò incalzato dalla necessità di un incremento costante delle entrate, senza un concomitante contenimento delle spese, sicché gli fu impossibile "levare lo inquinto", l'addizione del 5%, subita come il più ingiusto dei balzelli e la più odiosa delle estorsioni. Eppure, anche sul versante delle finanze statali, L. agì seguendo un'esigenza di razionalizzazione, secondo una visione dello Stato come macchina da far funzionare regolarmente nel suo complesso. Per questo i quattro segretari che lo affiancarono non sono considerabili una cricca di favoriti, piuttosto rispondevano alla suddivisione di competenze interagenti. Durante il governo di L., il Ducato fu pervaso di operosità: canalizzazioni, arginature, coltivazione del riso, coltivazione della seta, fortificazioni; a Pavia, cure per la certosa, il duomo, il castello e incremento della ragguardevole biblioteca di questo; a Vigevano, il potenziamento della residenza ducale, il riassetto del borgo, la realizzazione, con la Sforzesca, di una fattoria modello; a Milano, i lavori per la fabbrica del duomo, la manutenzione del castello, l'erezione della chiesa delle Grazie e del lazzaretto.
Splendida si presentava la corte milanese, effervescente, festosa, fitta di feste e banchetti, musiche, recite, "canti e soni", balli. E tanti i letterati che la frequentarono - il Bellincioni, Antonio Cammelli (detto il Pistoia), Gaspare Visconti, il Calmeta, Francesco Tanzi, Serafino Aquilano, Lancino Curti, Piattino Piatti -, facendo della Milano del Moro quasi una "Atene oggi", quasi un "Parnaso", ancorché non sfiorata dall'impennata della grande poesia. "Salus litterarum" appariva L., in una corte fattasi - lo riconosce Isabella d'Este - "scola [(] di queloro che sano" e in una Milano intellettualmente fervida, doviziosa di "templi et magni edifici", "vera calamita" per i "mirabili e singulari ingegni", dove fu istituita un'accademia della quale erano lettori i migliori docenti di Pavia, nella quale facevano lezione Demetrio Calcondila, Giorgio Merula, Luca Pacioli, Franchino Gaffurio.
Piuttosto che agli scritti in suo onore, agli encomi in versi e in prosa, L. prestò attenzione ai Commentarii delle gesta paterne redatti da Giovanni Simonetta, fratello dello sventurato Cicco, considerandoli quale introduzione allo svolgimento della propria reggenza, quasi questa fosse l'autentica erede dell'operato di Francesco Sforza. E, dunque, il testo fu sottoposto alla revisione di Francesco Dal Pozzo e di Francesco Filelfo e poi, non bastandogli che iCommentarii uscissero in latino, nel 1483, li volle stampati in volgare, tradotti da Cristoforo Landino, nel 1490. Per non passare alla storia come usurpatore, benché il potere lo avesse sostanzialmente usurpato, L. delegò alla storiografia il compito di collegarlo alla figura paterna (l'artefice, a suo avviso, del Ducato sforzesco), di valorizzare la sua presenza in termini di continuità e sviluppo, di farla coincidere con il consolidamento e il perfezionamento del Ducato. Per risaltare nella storia complessiva di Milano si affidò al Corio, a stipendio sin dal 1485, incaricato di un'opera di respiro, seriamente documentata, per le cui ricerche, il 1( ott. 1497, L. ordinò gli fosse data libertà di accesso "ad explorandas veteres scripturas".
In questa linea trovarono spazio l'"ornamentum" della capitale, la convocazione della tecnica, la progettualità urbanistico-architettonica, il rigoglio delle arti figurative: le "cose" artistiche gli erano "sommamente a core", come scriveva, il 29 giugno 1497, al consigliere e segretario Marchesino Stanga. I grandi artisti L. li avrebbe voluti tutti attorno a sé. Il Bramante fu inquadrato come "ingegnere e pittore". Ma soprattutto fu impegnato il multiforme genio di Leonardo, capace di "ruinare omni rocca nemica" in guerra, di soddisfare ogni esigenza edificatoria, idraulica, urbanistica, avveniristica, "in tempo di pace", e attivo, fino al dicembre 1499, come ingegnere camerale, escogitatore di macchine, e anche scenografo per gli eventi di corte. Per la festa del Paradiso, offerta da L. in castello al nipote e alla sua sposa, il maestro mise in scena, per l'appunto, il paradiso, con i sette pianeti "che giravano". Come pittore, fu incaricato dell'"opera del refettorio delle Gratie principiata", con l'affresco della Cena, e dei ritratti di Beatrice d'Este, la moglie di L., e di altre amate, ossia Cecilia Gallerani, raffigurata come "la dama con l'ermellino", e Lucrezia Crivelli, l'ultima favorita, donne dalle quali L. ebbe rispettivamente uno e due figli. Ancora a Leonardo, L. commissionò un colossale monumento equestre a gloria di Francesco Sforza e dell'"inclita casa sforzesca", riprendendo un'idea del fratello Galeazzo Maria vagheggiante, per il padre, una statua "de bronzo" a cavallo: nell'autunno del 1493 fu esposto, nel cortile vecchio del castello, il modello in creta (poi perduto), ma la fusione non fu realizzata.
Prelevato, il 17 apr. 1500, dal castello di Novara, L. fu tradotto - per Asti (dove gli fu urlato contro "a morte") e Susa - a Lione, dove giunse il 2 maggio. Luigi XII, che avrebbe rifiutato ogni incontro, volle un ingresso umiliante per L.: circondato da arcieri, su di una mula, con addosso una "vestizola de zambeloto". Sistemato provvisoriamente nel castello di Pierre Encise, L. fu trasferito poi nel possente castello di Lys Saint-George, nel Berry, presso Bourges. Qui, nel marzo 1501, il medico regio "maistro Salomon" lo descrisse "macro", con gli "occhi incavati". Ma poi prevalse l'adattamento alla prigionia, se - come riferiva nell'ottobre 1502 Domenico Trevisan, tornando a Venezia dall'ambasciata di Francia - L., in quel "castello prexon", giocava a carte e alla balestra e pescava "ne la fossa", essendo "più grasso che mai". La sorveglianza a cui era sottoposto si fece più stretta dopo un maldestro tentativo di fuga e nel 1504 fu trasferito nel castello di Loches, in Turenna.
Qui L. morì, "catholicamente e da buon cristiano", il 17 maggio 1508.
Tratto da treccani.it
Piaciuto questo Articolo? Condividilo...
Lifestyle
Oroscopo
L'Oroscopo della settimana, a cura del Prof. Leonardo Affrica con l'ausilio del Mago Ottonello
L'Oroscopo della settimana, a cura del Prof. Leonardo Affrica con l'ausilio del Mago Ottonello
L'Oroscopo del Giorno del Prof. Leonardo Affrica
L'Oroscopo della settimana, a cura del Prof. Leonardo Affrica e del Mago Ottonello
L'Oroscopo della prossima settimana, a cura del Prof. Leonardo Affrica