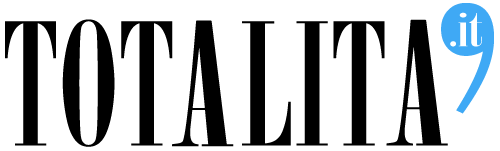Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.
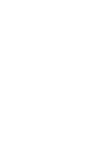
10 ottobre 1813
Giuseppe Verdi, e i suoi «anni di galera»
Nato in seno ad una famiglia molto modesta, ebbe la fortuna di contare sin da data precoce sulla protezione di Antonio Barezzi
di Totalità
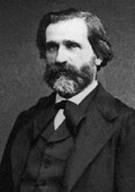
Giuseppe Verdi
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, nasce il 10 ottobre 1813 a Roncole di Busseto.
Compositore contemporaneo di Wagner, e come lui eminentemente drammatico, Verdi è stato il grande sovrano della scena lirica europea nella seconda metà del XIX secolo. La sua arte, però, non era di carattere rivoluzionario, come quella tedesca, al contrario, per lui ogni rinnovazione doveva cercare la sua ragione nel passato. Di conseguenza, senza tradire i tratti più caratteristici della tradizione operistica italiana, soprattutto nella concezione della scrittura vocale, riuscì a dare alla sua musica uno sbocco nuovo, più realistico ed opposto ad ogni convenzione non giustificata.
Nato in seno ad una famiglia molto modesta, ebbe la fortuna di contare sin da data precoce sulla protezione di Antonio Barezzi, un commerciante di Busseto affezionato alla musica che credette nelle sue doti dal primo momento. Grazie al suo aiuto, il ragazzo avrebbe potuto trasferirsi a Milano per studiare al Conservatorio, il che non riuscì perché, sorprendentemente, non riuscì a superare gli esami di ammissione.
Dopo aver studiato con Vincenzo Lavigna, che lo introdusse alla musica italiana del passato e a quella tedesca, venne nominato insegnante di musica a Busseto (1836), lo stesso anno in cui si sposò con la figlia del suo protettore, Margherita Barezzi. Il successo ottenuto nel 1839 a Milano, per la sua prima opera, Oberto, conte di San Bonifacio , gli procurò un contratto con il prestigioso Teatro alla Scala. Tuttavia, il fallimento del suo successivo lavoro, Un giorno di regno e, soprattutto, la morte della moglie e dei due figli, gli procurò una profonda depressione che lo portò a considerare l’ abbandono della carriera musicale.
Fortunatamente non lo fece: la lettura del libretto Il Nabucco gli restituì l'entusiasmo per la composizione.
Lo spartito, inaugurato alla Scala nel 1842, ricevette un'accoglienza trionfale, non solo per gli innegabili valori della musica, ma anche per le sue connotazioni politiche, poiché, al momento, l’ Italia era oppressa e divisa, e il pubblico si sentì concorde col conflitto ricreato nel dramma.
Con questo successo, Verdi non solo ottenne la sua svolta come compositore, ma divenne anche il simbolo della lotta patriottica per l'unificazione politica del paese. Le opere I Lombardi alla prima Crociata e Ernani condivisero le stesse caratteristiche. Questi furono descritti da Verdi come i suoi "anni di galera", in cui, per il suo impegno come direttore di teatro, fu costretto costantemente a scrivere un'opera c dopo l'altra.
Questa situazione cominciò a cambiare dopo l'uscita, nel 1851, di Rigoletto e, due anni più tardi, con Il Trovatore e La Traviata , i suoi primi immensi capolavori. Da allora poté realizzare solo opere di suo gradimento.
La sua produzione, per sua scelta, diminuì, ma aumentò proporzionalmente di spessore musicale.
E mentre le sue prime composizioni comunicavano appieno l'opera romantica italiana secondo il modello portato alla sua massima espressione da Donizetti, quelle scritte in questo periodo si caratterizzarono per la ricerca della verosimiglianza drammatica al di sopra delle convenzioni musicali.
Aida (1871), illustrerà questa tendenza come le cabalette che scompaiono, le arie sono più brevi e sempre più integrate in una musica a flusso continuo, da non confondersi con il dramma sinfonico wagneriano , e la strumentazione si fa molto più attenta.
Praticamente ritiratosi dopo quest’ultima opera, ebbe, comunque, modo di comporre un paio di lavori, sia con libretti di Arrigo Boito che su testi di Shakespeare: Otello e Falstaff , il secondo un'opera comica molto affascinante composta quando il musicista era ormai prossimo agli 80anni. Fu il suo canto del cigno.
Morirà il 27 gennaio 1901 presso il Grand Hotel et De Milan.