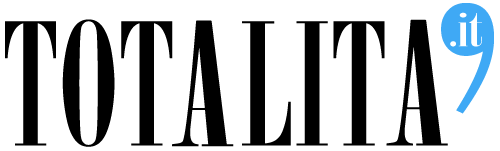Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.

Cento anni dalla morte
Giovanni Pascoli dialogherà con la morte per tutta la vita
La vita del poeta possiamo definirla "povera", all'insegna di una castità forzata...
di Domenico Del Nero

Giovanni Pascoli
Con la morte Giovanni Pascoli aveva dialogato per quasi tutta la vita: in quasi ogni sua lirica essa è una presenza, ora sottintesa ora evidente, quasi un angoscioso punto interrogativo – o esclamativo – nell’immenso mistero dell’esistenza umana. Esattamente cento anni fa, il 6 aprile 1912, si aprirono quelle che in uno dei suoi capolavori, la lirica l’Assiolo, aveva definito le invisibili porte che forse non s’aprono più… Il male era stato rapido e spietato; nel febbraio di quell’anno, mentre si riposava a Castelvecchio, il poeta ebbe i primi sintomi di un tumore maligno al fegato; fu trasportato subito a Bologna ma i più illustri medici, accorsi al suo capezzale, poterono fare ben poco. Ebbe se non altro la consolazione di ricevere in tempo il telegramma che annunciava la sua dodicesima vittoria, con relativa medaglia d’oro, al concorso di poesia latina di Amsterdam; e di andarsene assistito dagli ultimi componenti del suo amatissimo “nido” familiare, le sorelle e il fratello Raffaele detto Falino, il quale tra l’altro fu all’origine di una polemica scoppiata subito dopo la morte del poeta: allontanò infatti dal morente il sacerdote con il viatico perché, come ebbe modo di dichiarare al Resto del Carlino, da laico Giovanni aveva vissuto e da laico aveva voluto morire. Ma chissà se il poeta si sarà ricordato della frecciata cattiva dell’amico e rivale d’Annunzio, il quale, seccato per alcune osservazioni di Giovanni sulla sua vita mondana, gli aveva scritto con crudele chiarezza che preferiva rischiare il collo durante una caccia alla volpe che passare le serate di fronte al fiasco …
In effetti, la vita del professor Pascoli, specie se confrontata con quella tumultuosa e inimitabile di D’Annunzio, si può ben definirla “povera”, all’insegna di una castità forzata intorbidata dal rapporto un po’ inquietante con le sorelle, soprattutto Ida il cui matrimonio (1895) costituì per lui un vero e proprio trauma (anche perché, almeno secondo Vittorino Andreoli, il rapporto si era spinto sino al limite dell’incesto;) e poi la materna ma un po’ asfissiante Maria (Mariù), che fu invece almeno in buona parte causa delle nozze mancate, nel 1896, del poeta con una cugina –pare- anche di bell’aspetto :“era una bella bruna, complessa, d’una trentina d’anni come me ma assai fresca e assai bene conservata”. Cos’ la stessa Maria aveva scritto a proposito di Imelde Morri, salvo poi aggiungere che non era assolutamente adatta al fratello perché mancava di tenerezza e espansività. Invece, malgrado il nome improbabile e decisamente poco poetico, la fresca Imelde avrebbe potuto essere un toccasana per il poeta, che continuò invece a vivere nel suo nido in Garfagnana , a Castelvecchio di Barga in quella casa dapprima presa in affitto, poi acquistata, che divenne veramente il centro del suo piccolo mondo georgico.
Del resto, si potrebbe dire che a Giovanni Pascoli, nato a San Mauro di Romagna il 31 dicembre 1855, la vita aveva riservato abbastanza sorprese in giovane età. A partire da quel maledetto 10 agosto 1867 quando il padre Ruggero, onesto (pare sin troppo) amministratore della grande tenuta la Torre dei principi Torlonia, fu vilmente assassinato da mano almeno ufficialmente anonima, anche se la vox populi faceva chiaramente nomi e cognomi di esecutori e mandante, ma la voce della giustizia non era abbastanza interessata a farsi sentire. Un doppio colpo durissimo per il poeta, colpito negli affetti più cari ma anche nel suo naturalissimo desiderio di una giustizia che inseguirà inutilmente per tanti anni. Ancora un mese prima di morire aveva scritto in una lettera che “ il perché del delitto stava nel desiderio di succedergli e diventare ricco, dove a Ruggero Pascoli bastava rimaner galantuomo” [1]; e infatti la ragione fu probabilmente proprio il posto di amministratore presso i Torlonia.
Mia madre alzò nel gran silenzio un dito: disse un nome … S’alzò alto un nitrito
Così termina la Cavalla storna, (dai Canti di Castelvecchio) sicuramente una delle liriche meno felici del poeta da cui intere generazioni di giovani sono stati afflitti sin da bambini, con il rischio di concepire una feroce antipatia per i cavalli e ancor di più per le poesie; ma anche delle tante prove che il poeta sapeva benissimo chi “ringraziare” per quella prima tragedia, che fu l’inizio di una serie di lutti che decimarono il suo nido familiare, e con esso la serenità e la gioia di vivere dell’adolescenza, bloccando in un certo senso la sua maturazione psicologica: il “fanciullino” oltre a esser il più celebre dei suoi manifesti poetici, sarà anche in un certo senso il suo atteggiamento nei confronti del mondo e della vita. E sempre questa giustizia mancata, il conseguente declassamento della sua famiglia, la povertà e le sofferenze sono in buona parte del suo secondo “choc”, l’arresto per motivi politici il 7 settembre 1879. L’incontro con Andrea Costa aveva spinto il poeta, profondamente assetato di giustizia, ad abbracciare la causa del movimento operaio internazionalista:
“Quanta prigione per nulla! O per molto, a dir vero: per sentimenti e idee. Fu nei primordi del socialismo italiano, in cui si processavano come malfattori quelli che aspiravano a togliere dal mondo il male; e si condannavano. Io protestai. E così ebbi occasione di meditar profondamente, per due mesi e mezzo d'un rigidissimo inverno, su la giustizia. Dopo la qual meditazione mi trovai allora assolto e per sempre indignato. Ai cari compagni di quel tempo un saluto!”.
Così il poeta scrisse in una nota all’edizione del 1903 dei Canti di Castelvecchio, ricordando i 4 mesi di galera subiti per aver manifestato a favore di alcuni compagni di Imola a loro volta arrestati. Una vicenda che si chiuse con la sua piena assoluzione, ma che, se non fosse intervenuto il suo maestro Giosuè Carducci a rimetterlo sulla retta via degli studi, avrebbe potuto provocare uno sbandamento forse definitivo. Ma da allora la sua vita corse su binari abbastanza sicuri e tranquilli, anche se il poeta non rinnegò mai la sua militanza socialista: un socialismo fatto di solidarietà e utopia, che ripudiava decisamente la lotta di classe (Pascoli non amò mai Marx) ma che puntava piuttosto a una sorta di collaborazione tra le classi.
Non sembra un ritratto molto attraente e in effetti non lo è: il poeta era piuttosto lamentoso e monotono, tanto che Enrico Ghidetti ha usato l’efficace formula di “alitosi spirituale” per definire l’atteggiamento e l’effetto che faceva Pascoli e che ritroviamo in certe poesie bamboleggianti e lacrimevoli, come il celebre “10 agosto” che ricorda il dramma paterno (che non manca, comunque, di momenti suggestivi) e situazioni lacrimevoli e sdolcinate che ricordano il peggior De Amicis (dato ma non concesso che ne esista uno migliore). Ma chi pensasse che Pascoli sia solo questo prenderebbe un terribile abbaglio, come in effetti l’hanno presso illustri critici e barbassori, a partire dal solito don Benedetto Croce, che nei confronti del poeta romagnolo fu talmente pesante che qualcuno, spiritosamente, creò la formula “Pascoli in Croce”. E fare la storia della critica pascoliana significherebbe mettere insieme un bel rosario di prevenzioni e pregiudizi, almeno sino alle lezione illuminante e geniale di Gianfranco Contini, che nel 1955 per la prima volta indicò le grandi novità del linguaggio di Pascoli, che facevano di lui, per certi aspetti, un vero e proprio apripista del Novecento, oltre che, insieme a D’Annunzio, il nostro miglior poeta decadente (basti pensare a quel capolavoro di perversione che è Digitale Purpurea.) Ma Pascoli, per molti aspetti, ebbe intuizioni geniali, veramente profetiche:
“Si stanno edificando delle Ninivi e Babilonie e delle Cartagini e Rome, mostruose, enormi, infinite. Esse conquisteranno, assoggetteranno, cancelleranno, annulleranno, intorno a sè, tutto, e poi si getteranno le une contro le altre con la gravitazione di meteore fuorviate. Che sarà di noi? Perchè ciò a me sembra fatale e necessario; come, in un altro ordine di cose, altro fato e altra necessità mi apparisce. Questa. Le ricchezze gravitano a trovarsi insieme nel medesimo tesoro. Il campicello è assorbito dal campo, il campo dalla tenuta, la tenuta dal latifondo, e via via. Intere nazioni, sto per dire, sono espropriate della loro proprietà fondiaria. Ahimè chi possiede i campi della terra Saturnia madre di biade e madre d’eroi? Li possiede il credito ipotecario. E questo chi è? È generalmente anonimo, ed è un creditore collettivo. Ma poco a poco, questa collettività si riduce e semplifica; i più forti ingoiano i più deboli: verrà tempo, in cui si potrà dinotare per nome l’unico possessore di tutto il mondo: un tiranno al cui servizio sia un genere umano di schiavi.”
E’ un passo tratto da un discorso del 1900 (Una sagra) ma per certi aspetti potrebbe esse stato scritto in questi giorni, tanto che ci permetteremmo di raccomandarne la lettura all’attuale presidente del consiglio, dato ma non concesso che uno come lui perda tempo con i poeti. E questa dimensione di veggente, di profeta, Pascoli la dimostra nelle sue poesie migliori, dove dietro quello che può sembrare un “quadretto” impressionistico si cela il senso angoscioso del mistero, della vita e della morte, come bene ha scritto recentemente su Totalità Laerte Failli. Veggente? Viene subito in mente Rimbaud e la sua Lettera del veggente, con il poeta come ladro di fuoco. Ma che ha a che fare il grande ribelle con il timido e riservato professor Pascoli? Forse non si sono mai “conosciuti”, eppure hanno in comune più di quanto si pensi: la capacità, che è propria solo dei vati, di attingere l’infinito con qualche illuminante bagliore:
Sali pensoso la romita altura
ove ha il suo nido l’aquila e il torrente,
e centro della lontananza oscura
sta, sapïente.
Oh! Scruta intorno gl’ignorati abissi:
più ti va lungi l’occhio del pensiero,
più presso viene quello che tu fissi:
ombra e mistero.
Così una splendida gemma di Myricae (Sapienza) che potrebbe essere l’epitaffio dello stesso poeta: a cui oggi possiamo solo dire grazie per essere stato, lui “fanciullino”, infinitamente più grande di tanti “adulti”.
Piaciuto questo Articolo? Condividilo...
-
Inserito da david il 09/06/2024 06:09:14
VERY GOOD POST. 볼사이트
-
Inserito da ANITA SCALI il 05/11/2020 15:14:58
Amici, se ho ritrovato il mio sorriso è stato grazie al signore Michel Combaluzier, che ho ricevuto un prestito di €40.000. È stato attraverso un amico che ho incontrato questo uomo onesto e generoso che mi ha aiutato a ottenere questo prestito. Quindi ti consiglio di contattarlo e lui ti soddisferà. Ecco il suo indirizzo email : combaluzierp443@gmail.com
-
Inserito da piccolo da chioggia il 07/11/2013 10:48:18
al lettore di questo bello scritto del professor Accolla: sull'internet è visibile una significativa fotografia di Pascoli con Puccini in piedi, sullo sfondo di un giardino. anche le foto dicono molto e ciò si sa da sempre. la foto in questione rende un Pascoli sorridente. cosa, questa, grata per tutti noi ammiratori del grande Poeta romagnolo. Puccini, al solito è l'apuano "magister elegantiarum": alto, abbigliato con straordinario stile e, come riportano tutti coloro che lo videro, armonico nel fisico e bello di viso.
3 commenti per questo articolo
Cultura
DER IUNGE LORD: un trionfo meritato. L'opera di Henze stupisce e incanta il pubblico fiorentino
La grande musica russa: Daniele Gatti incanta il pubblico fiorentino con Stravinsky e Prokof'ev
SALOME: un grande inizio per l'87° festival
Grande diva: Jessica Pratt incanta con Norma. Uno spettacolo di alto livello trionfa al Maggio Musicale
RIGOLETTO: trionfo del capolavoro verdiano al teatro del Maggio
Libri
Smarrimenti e fragilità dell'uomo contemporaneo: i racconti di Italo Inglese, una boccata d'ossigeno contro la banalità.
POLIS: argomenti per una controrivoluzione. Un libro nettamente - e fortunatamente - in controtendenza.
Quel ragazzo inglese che poteva cambiare la storia: solo un romanzo, ma da leggersi d'un fiato
Rassegna di novità librarie dicembre 2019
Howard Phillips Lovecraft, Sogni, incubi & fantasticherie
La Settimana del Poeta
Il tardo simbolismo di un poeta che esordì 50enne dopo la morte della madre
Il più grande poeta erotico del '900
Sinestesie, suoni e colori: gli effetti speciali nella poesia di questo grande poeta
Eliot italiano guardò a Dante meglio e più di chiunque nel suo tempo
«Vogliamo entrare nelle nostra stanza, ...e farci un po' di primavera?»