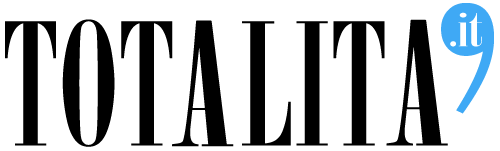Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.
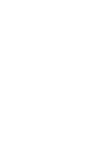
Menù intorno a Sorelle d'Italia
Zuppa di ceci meneghina di Teresa C. Confalonieri
Lo scrittore francese Stendhal amava Milano e anche la sua cucina tradizionale
di Marina Cepeda Fuentes

Teresa Casati Confalonieri
Quando lo scrittore francese Stendhal - pseudonimo di Marie-Henri Beyle - si trovava a Milano nel 1816, al suo secondo viaggio in Italia, fu invitato a cena in uno degli eleganti salotti letterari che, nella capitale dell’allora Regno Lombardo Veneto governato dagli austriaci, animavano le signore della buona società meneghina. L’invito era per il 4 novembre, festività del santo patrono della Lombardia, san Carlo Borromeo, e la tradizione imponeva di festeggiarlo degustando una tipica “zuppa di ceci”.
In quei salotti Stendhal aveva frequentato molti intellettuali, specialmente di spirito liberali, patrioti che cominciavano a complottare per l’unificazione di un’Italia che era stata divisa dopo il Congresso di Vienna del 1814.
Fra i più celebri quello di Clara Maffei, moglie del poeta patriota Andrea Maffei, era il prediletto da Massimo d’Azeglio. Ma era anche molto frequentato dai mazziniani quello della tenace Bianca Milesi, la prima donna affiliata alla Carboneria e la prima ad essere arrestata dagli austriaci; oppure quello della bella, colta e audace principessa Cristina di Belgioioso.
Uno dei cenacoli di Milano più ambiti dagli intellettuali milanesi lo animava la fedele patriota Teresa Casati Confalonieri, affiliata alla Società Segreta delle Giardiniere, la sezione femminile della Carboneria cui invece apparteneva il marito, Federico Confalonieri, che fu rinchiuso per molti anni nel temibile carcere austriaco di Spielberg.
Nel suo salotto si riuniva il fior fiore della cultura e della politica della città, soprattutto per complottare contro il governo austriaco: Stendhal, simpatizzante della Carboneria, vi conobbe lo scrittore Silvio Pellico anche lui finito a Spielberg dove scrisse “Le mie prigioni” uno dei libri fondamentali della storia del Risorgimento; ma anche il poeta Giovanni Berchet, che partecipò alle Cinque Giornate di Milano nel 1848, e fra molti altri, la contessa Matilde Viscontini Dembowski, anche lei affiliata Giardiniera, della quale Stendhal, che la chiamava Métilde nei suoi componimenti poetici, fu infelicemente innamorato per decenni.
Lo scrittore francese amava Milano e anche la sua cucina tradizionale, specialmente la “cotoletta alla milanese”, fritta nel burro, che loda nel suo “Viaggio in Italia” e che alcuni studiosi ritengono risalente proprio al periodo austriaco, tra il 1814 e il 1859, l’anno in cui, finalmente, nella prima tappa unitaria, il Regno Lombardo-Veneto fu annesso a quello sabaudo di Sardegna. Ma a sostenere la paternità meneghina della “cutelèta” intervenne addirittura il temibile maresciallo Radetzky il quale in una sua lettera a Vienna scrisse di aver scoperto a Milano la famosa costoletta riportandone poi la ricetta.
Stendhal frequentava anche gli accoglienti Caffè milanesi dove, fra gli avventori, covavano le ansie e le speranze dell’Italia preunitaria: fra i più celebri c’era il “Demetrio”, dove un gruppo di intellettuali patrioti fondarono la rivista “Il caffè”. Ma anche il “Caffè dei Servi”, il “Due colonne”.
Negli anni dei Moti, tra il 1848 e il 1860, gli scapigliati e i politici che contavano si riuniscono al “Cambiaso”, di fronte al teatro della Scala, chiamato poi popolarmente il “Caffè della Cecchina” dove si riunivano i sostenitori di Cavour, in contrapposizione al “Caffè della Peppina” che raccoglieva i mazziniani in via Cappello e che avrebbe ispirato negli anni Ottanta del secolo scorso una delle canzoncine dello Zecchino d’oro col ritornello più canticchiato in assoluto: “Il caffè della Peppina non si beve alla mattina né col latte né col the: ma perché, ma perché?”.
In quello però ottocentesco frequentato anche dallo stesso Mazzini quando era a Milano, così come nel “Caffè dell’Accademia”, oppure nel “Caffè Nuovo” o al Casino dei Nobili, il preferito di Stendhal, lo scrittore innamorato di Milano, il caffè veniva servito con la “panéra”, cioè con la panna, talmente di moda nelle caffetterie milanesi, da indurre il Foscolo ha ribattezzare Milano con il nomignolo di “Paneropoli”.
Ma ritorniamo a quel 4 novembre 1816, quando per la prima volta, Stendhal avrebbe assaggiato la zuppa di ceci in onore di san Carlone, come i lombardi chiamano affettuosamente il loro protettore: una singolare usanza gastronomica di cui gli aveva parlato l’amico, politico e intellettuale Melchiorre Gioia, che le illustrò anche la bontà della tipica minestra meneghina.
La parola deriva dal diminutivo di Domenico, in milanese Domenegh e Menegh, una maschera della Commedia dell’arte che s’identifica con la città di Milano e che fu introdotta in teatro nel Seicento con la tipica immagine del personaggio popolare giunta ai giorni nostri, il Meneghino, che divenne, a metà Ottocento, il simbolo dell’animo patriottico milanese contro la dominazione asburgica.
Ad un secolo prima risale invece la nascita del protettore della Lombardia, san Carlo Borromeo, nato il 1538 ad Arona, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore: era alto più di un metro e ottanta e di corporatura robusta e perciò amava mangiare anche quando i precetti ecclesiastici lo costringevano all’astinenza; i suoi digiuni infatti non consistevano nella privazione assoluta dal cibo, ma secondo l’uso ecclesiastico antico, nel consumare un solo pasto al giorno.
E in quelle occasioni il grande arcivescovo di Milano mangiava abbondanti minestre e zuppe accompagnate da pane di segale. Fra le sue preferite c’era la “zuppa di ceci” che durante la Quaresima si faceva preparare senza il maiale, sebbene prediligeva la ricetta tradizionale a base di verza e le parti meno nobili del porco: forse per questo motivi san Carlo Borromeo è diventato il protettore contro le ulcere, i disordini intestinali, e le malattie dello stomaco!
Ebbene, dalle cronache dell’epoca e dai diari di Stendhal si deduce che quasi certamente fu la signora Teresa Casati Confalonieri ad invitarlo nel suo salotto, quella sera del 4 novembre 1816, per la tradizionale degustazione della squisita, quanto sostanziosa, “zuppa di ceci” che tanto piaceva a san Carlone e che forse perciò è diventata simbolo meneghino di amicizia.
Ecco dunque la tipica ricetta della “zuppa di ceci” alla milanese, da consumare alla maniera di san Carlo Borromeo, come piato unico.
Ingredienti per 4 persone:
500g ceci ammollati
150g tempia di maiale
150g cotenne fresche di maiale
50g lardo
1 cipolla
1 gambo sedano
1 carota
1 verza o cavolo cappuccio
sale

Mettere i ceci in ammollo per 24 ore in acqua tiepida con un pizzico di bicarbonato. All’indomani preparare un soffritto con il lardo e la cipolla tritati; unirvi le cotenne e la tempia di maiale tagliate a pezzi e aggiungere le verdure precedentemente insaporite affettate grossolanamente.
Unire il tutto ai ceci che, in precedenza sono stati cotti per circa un’ora in una pentola con acqua fredda non salata, oppure nella pentola a pressione per una ventina di minuti. Cuocere ancora finché tutto sarà tenero, quasi sfatto, e servire caldo. Accompagnare con un bicchiere di vino rosso corposo.
Piaciuto questo Articolo? Condividilo...
-
Inserito da piccolo da Chioggia il 19/11/2013 12:38:54
bello il ricordo del nostro indimenticabile Henri Beyle, che, tra l'altro, ne "la certosa di Parma" ricorderà anche lo zabaglione padovano del Pedrocchi. meno bello il ricordo di quei patrioti che, senza volerlo probabilmente, ci han consegnato uno stato sabaudo, gonfio di retorica, accentrato, inefficiente, per molti oscuri aspetti forse anche criminale. ecco poi il motivo pel quale i meneghini chiamavano il Santo "el Carlun", pronunciando la u alla francese...
-
Inserito da Loredana il 26/03/2012 17:36:01
Adorabile! Ho persino scoperto le radici della canzoncina del Caffè della Peppina, grazie a questo articolo...e una variante allettante della zuppa di ceci, oltre alle notizie storiche. Quanta ricchezza in un solo scritto!