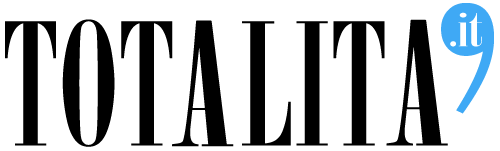Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.

Giuseppe Ungaretti
Il Nobel mancato al più grande poeta del '900
Interviene sulla tecnica poetica e sull'espressione tentando di conciliare l'inconciliabile nella lingua
di Giovanni F. Accolla

Giuseppe Ungaretti
Tra le tante cose incomprensibili sulla cosiddetta fortuna letteraria di alcuni autori italiani, a mio avviso, una delle più oscure rimane il mancato Nobel a Ungaretti. Perché l’Accademia di Svezia lo ha assegnato a Quasimodo e poi a Montale e non Ungà? Montale è stato senza dubbio un grandissimo poeta, direi un poeta sommo (su Quasimodo il mio giudizio è più complesso), ma Ungaretti è molto più poeta. È il più poeta di tutta la sua generazione!
Così, temo che la prefazione di Benito Mussolini alla seconda edizione de “Il Porto sepolto” nel 1923, non sia stata soltanto la causa che lo costrinse a riparare per un bel lasso di tempo in Brasile ad insegnare all’Università di San Paolo, ma fu anche il motivo per il mancato riconoscimento. Altrimenti per quale altro motivo? Lo ripeto senza timore di smentita: Giuseppe Ungaretti è il più importante poeta italiano del Novecento.
Lo è perché interviene sulla tecnica poetica e sull’espressione, in maniera risolutiva denunciando il definitivo disaccordo tra segno e significato, proprio come è stato nell’arte contemporanea; lo è perché lavora sulla lingua nel tentativo di conciliare l’inconciliabile (come la filosofia del suo tempo), tendendo più al silenzio che alla parola la quale, quando si pronuncia, è “squarcio - appunto - nel silenzio”. Perché per Ungaretti - ma ripeto, per quasi tutta la sua generazione che meglio di chiunque altro egli interpreta - la poesia non significa, è.
È proprio l’alto grado di rappresentatività di un momento culturale e storico che fa dell’opera di Ungaretti, e de “Il Porto sepolto” in particolare, un unicum che, costruito solo apparentemente in modo soggettivo ed empirico, riferisce di uno sforzo che sembra collettivo e storico. Tanto che credo sia legittimo leggere quest’opera come una eccezionale testimonianza: di qui la sua suprema riuscita dal valore classico (dacché espressione di una tradizione abissale, che rifugge da prospettive sociologiche) e per giunta in linea con un intero movimento di un epoca.
Troppo sbrigativamente la critica letteraria ha contrapposto, infatti, il concetto di Avanguardia con quello di “ritorno all’ordine”: faceva comodo alle mode del dopoguerra, e alla storiografia generale che ha dettato parole e giudizi mai poi affrancati da coloro che li pronunciarono. La storia, per così dire “cronologica”, che si crede obiettiva, è invece indifferente come certa scienza e come tale, classifica tutto senza qualificare nulla per davvero.
Il discorso si farebbe troppo lungo per il respiro di un articolo (quanto per me stesso visto che ormai ho più fiuto che fiato), ma nella poesia di Ungaretti (come in diverse prove di altri poeti italiani), dove per molti critici stupefatti convivono perfettamente eversione avanguardistica e restaurazione letteraria, dove la tradizione è rovesciata e ricostituita, c’è la prova più esplicita che le Avanguardie - dopo il loro lavoro di smottamento dell’antico - raggiungono il loro compimento e la loro riuscita, rientrando con rinnovato vigore e con il sacrosanto portato di modernità, nel solco della tradizione.
Mi piace congedarmi con una poesia tratta dalla prima silloge di Ungaretti. Si intitola: “C’era una volta” ed è arcinota, ma non celebrata quanto altre della medesima raccolta. La trovo straordinaria, leggera e perfetta. Attenzione: leggera come il marmo quand’è lavorato da un grande scultore, perfetta come una perla degli abissi la cui costituzione ci trascende. Ed è in fine paradigmatica, mi pare, per quanto ho sostenuto precedentemente. C’è un sottotitolo (Quota Centoquarantuno, l’1 agosto 1916), come in tutti i componimenti de “Il Porto sepolto” che inchioda quelle parole e quelle suggestioni ad un qui ed ora, ed ad un io inequivocabili, ben presto liberati - per magia poetica - in un’esplosione atemporale e in una dimensione universale che supera la stessa esperienza individuale (che altro è un poeta se non un uomo con in sé una grande porzione di assoluto?).
L’espediente è spiazzante e fantastico: si notino i due blocchi di versi (privi di punteggiatura e dalla metrica frantumata), dall’osservazione del luogo il declivio del bosco, nel verso successivo diviene “di velluto verde” e spinge Ungaretti (e noi con lui) verso un’altra dimensione, in una atmosfera della memoria tanto corporale, quanto spirituale. Si salta anche tipograficamente sull’altro blocco di versi: “Appisolarmi là” (ma dove?) / “solo” (mica con nessun altro) / “in un caffé remoto” (ma non eri nel bosco?) / “con una luce fievole” (attenzione all’aggettivo che non corrisponde al soggetto) / “come questa” (questa che?) / “di questa luna”. Ecco, ripete “questa” per tornare dov’è. Ha chiuso il cerchio, con perfezione logica fuori da ogni logica reale. Dentro c’è rimasto il sentimento, la folgore che governa il mondo e la verità dell’anima, intatto per sempre, a godimento di tutti noi.
C’era una volta
Quota Centoquarantuno, l’1 agosto 1916
Bosco cappuccio
ha un declivio
di velluto verde
come una dolce
poltrona
Appisolarmi là
solo
in un caffé remoto
con una luce fievole
come questa
di questa luna
Piaciuto questo Articolo? Condividilo...
Cultura
AIDA: il costo della guerra, il trionfo del dolore. Una suggestiva lettura del capolavoro verdiano.
DER IUNGE LORD: un trionfo meritato. L'opera di Henze stupisce e incanta il pubblico fiorentino
La grande musica russa: Daniele Gatti incanta il pubblico fiorentino con Stravinsky e Prokof'ev
SALOME: un grande inizio per l'87° festival
Grande diva: Jessica Pratt incanta con Norma. Uno spettacolo di alto livello trionfa al Maggio Musicale
Libri
Smarrimenti e fragilità dell'uomo contemporaneo: i racconti di Italo Inglese, una boccata d'ossigeno contro la banalità.
POLIS: argomenti per una controrivoluzione. Un libro nettamente - e fortunatamente - in controtendenza.
Quel ragazzo inglese che poteva cambiare la storia: solo un romanzo, ma da leggersi d'un fiato
Rassegna di novità librarie dicembre 2019
Howard Phillips Lovecraft, Sogni, incubi & fantasticherie
La Settimana del Poeta
Il tardo simbolismo di un poeta che esordì 50enne dopo la morte della madre
Giovanni Pascoli dialogherà con la morte per tutta la vita
Il più grande poeta erotico del '900
Sinestesie, suoni e colori: gli effetti speciali nella poesia di questo grande poeta
Eliot italiano guardò a Dante meglio e più di chiunque nel suo tempo