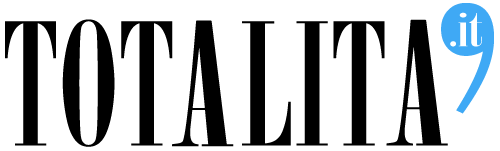Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.
Editoriale
Come nello specchio di Dorian Gray la bellezza di Roma del film di Sorrentino
Una città che resta caput mundi anche nella metafora grandiosa e avvilente del degrado

di Giuseppe del Ninno
 inistri costretti a dimettersi per infedeltà fiscale o per rapporti poco chiari con uomini d’affari; ex presidenti del Consiglio inquisiti per reati che vanno dal concorso in attività mafiose alla concussione, dalla corruzione di giudici a quella di minorenni; assessori coinvolti in episodi boccacceschi e, ovviamente, in vicende di gestione illecita di fondi pubblici: un simile “sommario di decomposizione” potrebbe essere redatto non già spulciando le cronache di questa presunta “seconda Repubblica”, ma affonda le radici in anni molto lontani, antecedenti addirittura a Tangentopoli.
inistri costretti a dimettersi per infedeltà fiscale o per rapporti poco chiari con uomini d’affari; ex presidenti del Consiglio inquisiti per reati che vanno dal concorso in attività mafiose alla concussione, dalla corruzione di giudici a quella di minorenni; assessori coinvolti in episodi boccacceschi e, ovviamente, in vicende di gestione illecita di fondi pubblici: un simile “sommario di decomposizione” potrebbe essere redatto non già spulciando le cronache di questa presunta “seconda Repubblica”, ma affonda le radici in anni molto lontani, antecedenti addirittura a Tangentopoli.
Verrebbe da pensare che hanno ragione i critici della Casta per antonomasia – quella politica – se non fosse che non pochi esponenti della cosiddetta “società civile”, eletti o cooptati nei ranghi di quella politica, hanno dato e stanno dando prove a dir poco deludenti. Se poi si aggiungono i commenti non certo lusinghieri – e provenienti non da una sola, interessata, parte politica – sull’operato di “certi” magistrati, il quadro desolante del declino sembra completo.
Ora, dai drammi di un popolo e della sua patria, non di rado sono scaturite opere d’ingegno che non hanno soltanto favorito la comprensione di complessi fenomeni di costume o addirittura di eventi storici, ma ne hanno tramandato sintesi fulminanti per i posteri. La letteratura, la musica, perfino la cinematografia hanno potuto contare su veri e propri giganti del pensiero, di cui non è il caso di proporre ora un elenco che sarebbe per forza di cose largamente lacunoso.
Qui, andando al di là della più stretta attualità, vorrei limitarmi a chiosare un film che, senza essere un capolavoro, potrà rappresentare una boa segnaletica nella storia di una Città e della sua gente, in questi nostri anni. Alludiamo alla Roma messa in scena da Paolo Sorrentino nel recente “La grande bellezza”, autentico compendio visionario dei nostri giorni.
Il regista napoletano è fra i pochi cineasti in grado di armonizzare parola, immagine e colonna sonora, ed è pure tra i pochi capaci di assimilare e rielaborare ispirazioni letterarie e cultura cinefila, per offrire allo spettatore un prodotto finito originale che emoziona e, al tempo stesso, fa riflettere. Quanto alla colonna sonora, la scelta rispecchia quella caleidoscopica e variegata dell’intero film, spaziando dal Dies Irae di Preisner al Forever di Antonello Venditti (chiamato pure a interpretare se stesso, in una brevissima scena). Sorrentino poi non nasconde la nobile matrice letteraria del suo film, apertamente céliniano – e a Céline è dedicata l’epigrafe iniziale – e cioraniano, senza dimenticare, ovviamente, il “suo” Tony Pagoda di “Hanno tutti ragione”, sorprendente romanzo d’esordio dello stesso Sorrentino.
Quanto alle pellicole di cui “La grande bellezza” è tributario, sono evidenti gli echi felliniani (e non solo quelli di “Roma” e “La dolce vita”, ma anche di “Giulietta degli spiriti” e “Otto e mezzo”), non meno delle citazioni aggiornate di alcune pellicole di Ettore Scola, quali “La terrazza” e “C’eravamo tanto amati” (quest’ultima, in particolare, nel personaggio di Carlo Verdone, qui baffuto e sulla stessa lunghezza d’onda esistenziale di quello interpretato a suo tempo da Stefano Satta Flores, entrambi inurbati dal paesello d’origine con ambizioni artistiche e poi delusi dalla Città).
Intorno a Gep Gambardella – un Toni Servillo a cui si perdonano anche certe smorfiette istrioniche – giornalista coccolato nei salotti che contano e autore di un solo, fortunato romanzo scritto in gioventù, ruota una fauna di soggetti cinici, superficiali, nevrotici, tutti frequentatori della terrazza del nostro, con vista sul Colosseo, nel più ampio circuito dei salotti “à la page”, affollati da aspiranti stelline pronte a tutto e da facoltosi, annoiati “viveurs” della notte.
Ecco, proprio la Roma diurna, quella delle persone “normali”, quelle che in gran parte si sono tenute lontane dalle urne, in occasione delle recenti elezioni comunali, e che ogni giorno sono assillate dalla crisi montante, dal traffico e dai mille problemi irrisolti dell’Urbe, quella Roma, dicevo, nel film non appare: l’alter ego del regista, che prende il testimone dal Mastroianni felliniano, va a dormire quando si leva il sole, tanto per sottolineare che al centro degli interessi dell’Autore non sono le questioni sociali, politiche o addirittura alimentari, bensì il vuoto vertiginoso e tenebroso che sembra attrarre l’uomo dell’era del nichilismo. Per inciso, questa scelta di contenuti ci regala non poche sequenze in cui la città di tutti i giorni ci viene mostrata nella sua luce e nei suoi aspetti meno noti e più affascinanti, quali le banchine del Tevere, il fontanone del Gianicolo, l’Aventino delle Basiliche.
“Questo è il trenino più bello, perché non porta da nessun parte!”, è la sorridente, disperata affermazione di Gep, impegnato nell’ennesima sarabanda sulla sua terrazza, gremita di imprenditori volgari e artisti falliti, sotto gli occhi del misterioso inquilino del piano di sopra, oggetto della curiosità di Gambardella. L’invettiva di Sorrentino non risparmia nessuno: l’attrice che, al culmine di una performance en plein air, batte la testa contro un pilastro dell’Acquedotto Felice; così come i genitori dell’infelice bambina-prodigio che, in preda a una trance creativa, rovescia secchiate di colore su di una grande tela, sospinta e sfruttata dai genitori, sotto gli sguardi di un pubblico che finge ammirazione.
Ma ce n’è anche per la Chiesa, nel mirabile cameo di Roberto Herlitzska, porporato frivolo e mondano come i settecenteschi abati cicisbei. Con differenze, rispetto a questi ultimi, da non sottovalutare, e non solo perché la passione del cardinale di Sorrentino è costituita dalla gastronomia (oltre che dai salotti), invece che dalle dangereuses liaisons con le belle dame: Gambardella infatti lo assedia con una inattesa domanda di spiritualità, ponendogli in più occasioni, senza ottenere risposte, la questione dell’esorcismo, a cui il cardinale si dice si sia dedicato, prima di approdare, evidentemente sconfitto dal Signore di Questo Mondo, nelle sofisticate cucine della mondanità. Qui balena l’eco dei contes philosophiques e perfino delle “diaboliche” di Barbey d’Aurevilly, prima dello scivolamento nel grottesco, con l’entrata in scena di una monaca “santa” e grinzosa, condotta in società da un agente avido e privo di scrupoli, in una sorta di greve, ingiustificabile caricatura di madre Teresa di Calcutta.
Se poi ne “La dolce vita” si coglieva qualche vitalismo residuale, specie nella sequenza finale sulla spiaggia, qui la disperazione lascia ben pochi spiragli, ad esempio, nel sincero apprezzamento di una normalità fatta di serate davanti alla TV: “Che belle persone siete”, dice Gep ad una coppia di conoscenti, di cui si intuiscono le piccole gioie domestiche; e vibra il rimpianto di un passato irrimediabilmente perduto, nella sfera privata, con la sequenza del ricordo di un primo amore innocente e lontano; in quella pubblica, nelle scene della visita notturna ai tesori d’arte racchiusi nei palazzi aristocratici romani.
E’ come se lo stesso Sorrentino, tramite il suo alter ego più anziano, avvertisse il peso di un’età che non è tanto anagrafica, quanto appesantita da esperienze mortifere; proprio come l’atmosfera che si respira nella via Veneto che fu il toponimo della dolce vita, qui invece tenebrosa e deserta intorno a Gep, e che sembra abitata soltanto da un vorace, solitario riccone arabo, seduto in un caffè che vide gli effimeri trionfi di remoti nottambuli (altra metafora?). Ed è ancora la stessa atmosfera lugubre che si respira nel night, dove si esibisce una spogliarellista agée, interpretata da una convincente, malinconica Ferilli, figlia del proprietario, vecchio compagno di bagordi di Gambardella: l’ostinato, patetico esibizionismo della donna, incomprensibile perfino per il genitore, avrà una spiegazione tragica, di cui sarà depositario solo il nostro Gep.
Insomma, il contenuto di un baule colmo di suggestioni viene sciorinato davanti a noi, che restiamo col desiderio di rovistare ancora in questa Grande Bellezza, con l’amara sensazione di non aver colto – al pari di Gep – non solo i meccanismi dei giochi di potere che hanno portato all’inopinato arresto del misterioso vicino, ma neppure l’essenziale del “Grande Gioco” che noi tutti siamo stati chiamati a giocare.
Piaciuto questo Articolo? Condividilo...
il Banditore
Non possiamo nn dirci conservatori, e allora attenti con la santificazione della tecnologia
Quel che la Corte Suprema non ha considerando riguardo al divorzio
Perché la destra sta sparendo dall'agone politico
Mettete la museruola ai genitori incoscienti
Se le donne vincono quando in politica i migliori rinunciano
Editoriale
Terremoti, risate e ipocrisia
1995-2015 An, dopo l'illusione di una destra al governo il fallimento per manifesta incapacità
Lo tsunami Cofferati e lo struzzo Renzi
Tutti gli errori di Berlusconi pagati nei sondaggi che premiano la Lega
Quell'odioso doppiopesismo che elegge l'ipocrisia a sistema di giudizio