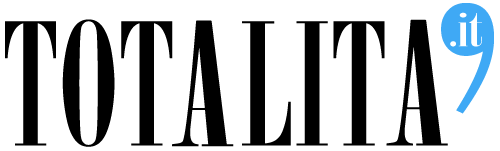Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.
Editoriale
Il successo della serie tv Gomorra: il nostro spietato ritratto
Un dramma senza catarsi, il bene non prova neppure a combattere il male, questa non una storia napoletana, ma italiana

di Giuseppe del Ninno
 amentiamo spesso la pochezza del discorso pubblico, l’incapacità delle classi dirigenti di proporre grandi visioni, l’inadeguatezza dei creativi nel forgiare potenti strumenti simbolici e spericolate griglie interpretative del reale.
amentiamo spesso la pochezza del discorso pubblico, l’incapacità delle classi dirigenti di proporre grandi visioni, l’inadeguatezza dei creativi nel forgiare potenti strumenti simbolici e spericolate griglie interpretative del reale.
Ebbene, in queste settimane ha riscosso un successo inatteso una ”fiction” trasmessa da Sky Atlantic: Gomorra. Si tratta di un lavoro a più mani, come e più che nei normali prodotti cinematografici; qui però, dati l’argomento – la camorra – e il titolo, si intuisce l’apporto decisivo di Roberto Saviano. Non appartengo alla schiera degli sperticati estimatori dell’opera capitale di Saviano e neppure del film di Matteo Garrone che poi ne è stato tratto, pur apprezzando della prima l’ibridazione di generi – soprattutto romanzo e inchiesta – e del secondo l’asciutta sceneggiatura e il montaggio serrato.
Nel caso della Gomorra seriale, tuttavia, il risultato raggiunto è di assoluto rilievo, soprattutto sul piano simbolico, grazie anche ad un “team” felicemente e armoniosamente composto, a partire dai tre registi fino agli attori - per lo più caratteristi sconosciuti al grande pubblico, ma capaci di una immedesimazione nei rispettivi personaggi con una naturalezza “sociologica” ai limiti del medianico - e proseguendo con gli sceneggiatori, gli scenografi e i fotografi, in grado di trasfigurare scenari realistici fino a tramutarli in suggestive, evidenti metafore.
Questa Gomorra si pone come uno dei possibili “contes philosophiques” del nostro paese e della nostra epoca, e poco importano i rilievi morali – o moralistici? – di chi paventa rovinose emulazioni dei comportamenti criminali messi in scena.
Sia chiaro: questa Gomorra non vuol essere una pedissequa riproduzione della realtà napoletana e quindi non ci si può limitare alla deprecazione e alla condanna di chi “lava i panni sporchi di famiglia” in pubblico, come a suo tempo fece una ipocrita democristianeria per il cinema neorealista e come, proprio in questi giorni, ha commentato Marco De Marco sul Corriere della Sera.
Napoli non è solo questo miscuglio di cinismo, di spietatezza, di violenza, è stato detto. E ci mancherebbe altro! Io credo che gli autori della saga del clan Savastano si prefiggessero altri e più ambiziosi obiettivi.
Qui la “cultura della camorra”, la trama consueta di ascese e declini, di tradimenti e vendette, il dramma delle “liaisons” tra il malaffare, la politica e la finanza (che purtroppo sembra essere una condanna secolare del nostro paese) possono essere interpretati non già e non solo in chiave di denuncia sociale, bensì come pretesto narrativo per raccontarci la nostra storia, per illustrare il nostro DNA di nazione, anche quando non si viola il codice penale.
E la narrazione, per essere più efficace e diretta, rinchiude i suoi capitoli, i suoi personaggi, i suoi scenari in una gigantesca monade che deliberatamente esclude la Napoli complessa e fascinosa, ricca di storia e di drammi attuali, in preda alle angosce comuni a tutta la Nazione per il suo futuro.
Non uno scorcio paesaggistico da cartolina viene offerto ai telespettatori, non un monumento celebrato; vengono però ritratti, sotto un cielo perennemente grigio o in una luce livida e artificiale, desolati e degradati scenari urbani, alternandoli con interni che vanno dal lusso kitsch della dimora del Capo allo squallore affollato delle carceri; il tutto evocando nomi e scorci di quella terra reale e dei suoi ormai consolidati addentellati metropolitani, da Milano a Barcellona, passando per Scampia e Giugliano, Poggioreale e Castelvolturno.
In questo inferno urbano senza riscatto, si muovono figure esemplari nella loro contraddittorietà: il capo della famiglia Savastano, insieme saggio e sanguinario, innamorato della moglie e preoccupato del futuro del figlio, temuto e rispettato perfino in carcere; la moglie, accorta stratega in assenza del marito, madre leonina, che non esita a scuotere il figlio fatuo e imbelle e a metterne a repentaglio la vita, per iniziarlo alla sua nuova carriera di Capo-clan; il figlio, intorno al quale la sceneggiatura traccia un tragico percorso di formazione; il luogotenente capace di sincera complicità col giovane boss, ma implacabile nella sua vendetta quando, assente il capo-Ulisse, si sente tradito da quelle squallide controfigure di Penelope e Telemaco; il boss del clan antagonista, feroce e bigotto al tempo stesso, come spesso è emerso dalle cronache di mafia.
Ancor più marcatamente che nei “noir” americani, in questa storia non vi sono Buoni che si contrappongono ai Cattivi: nel cupo castello di Camelot situato a Scampia, al di là dei frequenti baci e abbracci e delle ripetute dichiarazioni di fratellanza, la regola è quella che il giovane boss, ormai indurito dalle tappe della sua carriera, raccomanda al bambino che sembra prendere sotto la sua protezione: “Non ti fidare di nessuno, neanche di me”.
Lo Stato, le Forze dell’Ordine, i Tribunali sono talmente marginali da risultare quasi assenti nella narrazione, mentre la gente comune si ritira spaventata – non solo nella metafora narrata, ma anche nella realtà - di fronte alle scorribande in scooter dei giovani giannizzeri al comando di questo o quel luogotenente.
Qui siamo nel laboratorio di un redivivo Macbeth in versione plebea, ma non solo: abbiamo parlato di metafora, e qui si rispecchiano le possibili esistenze di tante persone “normali” che, onestamente, coltivano le proprie ambizioni e i propri complessi, amano, tradiscono e violano la legge, arrancano lungo tortuosi percorsi di crescita, spesso in danno di altri, pur senza impugnare le armi o esporsi a pericoli mortali. Qui c’è l’eco della “cattiva politica”, della corruzione, del punto zero dei valori morali, come emerge anche dalle sciagurate cronache di questi giorni; qui il “mostro” ha le sembianze di “bravi ragazzi”, di affettuosi padri e madri di famiglia, magari di sgangherati politicanti locali.
Se non fosse per i modi spicci e cruenti per risolvere le controversie, in Gomorra potremmo ritrovare la preoccupazione per il “business” e la concorrenza degli imprenditori “ordinari”, con in più la cura del “welfare” per i parenti degli uccisi e dei carcerati e il quasi ossessivo riferimento a nozioni positive ma ormai disattese e comunque stravolte, quali “onore” e “rispetto”, al punto da farci quasi dimenticare che questi affari si chiamano traffico di droga e riciclaggio di capitali “sporchi”; per tacere di tutto il nauseabondo repertorio di affari gestiti dalla malavita, che ormai non ha più soltanto radici locali, anche se continua a parlare un dialetto così stretto da richiedere i sottotitoli nel film.
Sotto questo profilo, insomma, parafrasando Flaubert con la sua Madame Bovary, Gomorra siamo noi, anche se riesce difficile accettarlo e, come nello sceneggiato, non si vedono poliziotti-nemici, perché spesso il nostro nemico è il nostro vicino, il nostro concorrente, perfino il nostro amico; insomma, siamo noi stessi.
Certo, si tratta di una metafora estrema e ingenerosa verso i tanti che si adoperano per raddrizzare la barca malandata della nostra patria, e certo l’Italia non è solo criminalità; ma sarebbe stato arduo mettere in scena una diversa metafora, imperniata su altri caratteri di questo paese, come l’inerzia, l’incapacità, la disperazione. E poi, si sa, le storie edificanti non sono più di moda e le buone notizie “non fanno notizia”…
Piaciuto questo Articolo? Condividilo...
il Banditore
Non possiamo nn dirci conservatori, e allora attenti con la santificazione della tecnologia
Quel che la Corte Suprema non ha considerando riguardo al divorzio
Perché la destra sta sparendo dall'agone politico
Mettete la museruola ai genitori incoscienti
Se le donne vincono quando in politica i migliori rinunciano
Editoriale
Terremoti, risate e ipocrisia
1995-2015 An, dopo l'illusione di una destra al governo il fallimento per manifesta incapacità
Lo tsunami Cofferati e lo struzzo Renzi
Tutti gli errori di Berlusconi pagati nei sondaggi che premiano la Lega
Quell'odioso doppiopesismo che elegge l'ipocrisia a sistema di giudizio