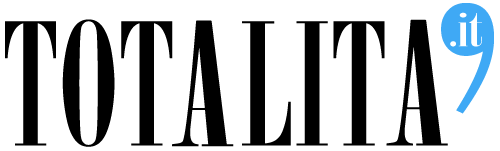Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.

PIER PAOLO PASOLINI
Il pianeta difficile di un poeta che assomigliò a Mishima
Come Dante e Pound poeta della diaspora col mito della tradizione
di Giovanni F. Accolla
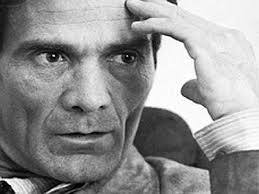
Sottrarre Pier Paolo Pasolini dalla retorica del martirio, dalle mille piste interpretative che nulla aggiungono alla comprensione della sua opera, dovrebbe essere un dovere per tutti coloro che, non solo lo hanno letto e lo leggono, lo amano e lo hanno amato; ma anche per quelli che ne hanno apprezzato al meno l’intelligenza, l’impegno, il coraggio. Eppure, senza sosta, si danno alle stampe ricostruzioni, più o meno romanzate, delle dinamiche della sua morte e c’è sempre qualche “vedova”, più o meno legittima, che è pronta ad esclamare il proprio “giù le mani”, come se non ci fosse altro, oltre alla sua tragica fine, su cui ragionare.
Complotto o non complotto (sia chiaro, qui non si vogliono minimizzare le lacune e gli interrogativi ancora aperti sulla ricostruzione delle ultime ore di Pasolini), il caso della morte mette ingiustificatamente in ombra quella che in tutta evidenza, a me pare, la vera eredità di uno degli intellettuali più importanti del Secolo scorso, l’opera.
C’è un “al meno che”. Anzi, c’è un’ ipotesi che scombinerebbe i piani e che nel contempo metterebbe per davvero la parola fine (non sulle dinamiche, ovviamente) sull’intera vicenda Pasolini: quella di considerare la sua morte una parte integrante dell’opera.
Sto parlando della tesi nutrita da Giuseppe Zigaina in “Pasolini e la morte” (e in parte da Stefano Agosti in “Pasolini fuori di sè”) nel quale si sostiene che Pier Paolo Pasolini avesse iniziato, fin dal 1958, a concepire la sua opera come "messa in scena" della propria vita e che pertanto la sua morte sia stata da egli stesso organizzata. Pasolini, scrive Zigaina, si è fatto uccidere a Ostia (anche sul significato, il nome del luogo, si poterebbe riflettere) offrendosi come vittima sacrificale in una domenica del 1975 che coincideva con il 2 novembre, giorno dei morti.
La tesi - che a molti può, non a torto, far letteralmente rabbrividire - a me non pare buttata lì ad effetto, ed anzi, suffragata da diversi testi pasoliniani, darebbe un senso straordinariamente potente ad un intellettuale che più di chiunque altro ha intrecciato vita (intesa anche come corpo) e opera, in modo complesso originale ed efficace. Unico. Anzi, come solo precedente lo scrittore giapponese Yukio Mishima (e le analogie tra i due - come ha più volte acutamente spiegato Marcello Veneziani - non si esaurirebbero nel comune seppuku).
Da “Bestia da Stile”:
Proprio perché è festa.
E per protesta voglio morire di umiliazione.
Voglio che mi trovino morto col sesso fuori,
coi calzoni macchiati di seme bianco, tra
le saggine laccate di liquido color sangue.
Mi sono convinto che anche gli atti estremi
di cui io solo, attore, sono testimone,
in un fiume che nessuno raggiunge
– avranno avuto alla fine il loro senso.
E in “Poesia in forma di rosa”:
Quanto al futuro, ascolti:
i suoi figli fascisti
veleggeranno
verso i mondi della Nuova Preistoria.
Io me ne starò là,
come colui che
sulle rive del mare
in cui ricomincia la vita.
Solo, o quasi, sul vecchio litorale
tra ruderi di antiche civiltà,
Ravenna
Ostia, o Bombay - è uguale -
con Dei che si scrostano, problemi vecchi
- quale la lotta di classe -
che
si dissolvono...
Come un partigiano
morto prima del maggio del '45,
comincerò piano piano a decompormi,
nella luce straziante di quel mare,
poeta e cittadino dimenticato."
E ancora, in “Empirismo Eretico”:
“Finché io non sarò morto, nessuno potrà garantire di conoscermi veramente, cioè di poter dare un senso alla mia azione, che dunque, in quanto momento linguistico, è mal decifrabile”.
Ma attenzione, semmai questa ipotesi fosse autentica, quello di Pasolini non sarebbe un rito estetizzante (e neanche il collasso di un equilibrio mentale psico-fisico), ma una vera e propria ultima poesia scritta con il corpo, con il sacrificio della vita. Pasolini al primato della vita e della realtà, infatti, ha sacrificato tutto, anche la sua vocazione per una poesia assoluta e totalizzante, a una fondazione mitopoietica della realtà che i suoi versi affermano e drammaticamente (e continuamente) sconfessano. Pasolini ingaggiò un corpo a corpo con la storia pensando, come uomo del sul tempo, che la storia portasse in grembo la verità (mentre la storia, ora lo sappiamo, corrompe la verità), e nel contempo inseguì su vie parallele o più interiori, il sogno di una purezza perduta nell’origine del tempo o ancora presente nelle minute storie individuali.
Pasolini, quindi, non costruisce la sua vita come fosse un'opera d'arte, ma l'opera d'arte come fosse la vita, ed è questa è la cifra più forte autentica e drammatica della sua poesia. Egli è sostanzialmente scevro da gratuiti estetismi, da superficiali ed intellettualistiche finzioni, da giochi decadentistici. E’ troppo consapevole, moderno e colto. Insomma, Pasolini non è d'Annunzio, anzi è l’anti d’Annunzio per eccellenza: percorre il medesimo solco di reciproco scambio tra letteratura e vita, ma nel senso opposto. Vitalismo al servizio di un poesia che si vorrebbe diretta, intensa, autentica (o capace di rendere vera) come la vita. E semmai avesse qualche minima ombra di verità la mia ipotesi secondo la quale, all’interno della storia della poesia italiana del Novecento c’è una linea, una poetica non codificata, ma coerente di “poesia della vita” e “per la vita”, Pasolini sarebbe il massimo interprete, il punto d’arrivo e la dissoluzione.
Ho detto poesia, perché sono tra i quali (pochi ed eretici) pensano che un’indagine sul “pianeta” Pasolini, desiderosa di comprendere le istanze più autentiche di questo autore, debba prendere in esame principalmente l’opera in versi: il ciclo intero, da “La meglio gioventù”, per passare attraverso “L’usignolo della chiesa cattolica”, “Le ceneri di Gramsci”, “La religione del mio tempo”, “Poesia in forma di rosa”, “Trasumanar e organizzar” fino ad arrivare con coerenza (linguistica e non solo) alla “Nuova gioventù”.
Quello che non sempre si ha avuto l’onestà di riconoscere, è che molto del suo singolare fiuto nel distinguere e individuare, nel giudicare, comprendere e lottare, è retaggio e patrimonio, prima di tutto, del Pasolini poeta. E anche se un grande versificatore come Andrea Zanzotto si chiede, in apertura di un suo famoso saggio, se sia giusto considerare Pasolini soprattutto come poeta, vista l'eterogeneità e l’abbondanza di quanto ha scritto e nei più vari campi, il mio giudizio è che Pasolini fu molte cose, ma sopra ogni altra desiderò e volle essere poeta, pur essendo consapevole (o forse proprio per questo) delle contraddizioni e della difficoltà (la follia e l’anacronismo), di fare poesia nel mondo contemporaneo.
Vorrei far notare - come è stato anche altrove sostenuto - che la poesia è l'unico pezzo dell'organismo intellettuale e letterario di Pasolini che non si può sottrarre senza compromettere il tutto, è colonna vertebrale o, se si vuole, il cuore di tutto il sistema. La produzione poetica è, inoltre, la cartina di tornasole sulla quale individuare le fasi, gli scarti, le contraddizioni continue e le tensioni esistenziali e culturali di Pasolini uomo e intellettuale. E’ nella poesia che Pasolini stesso, nel corso della sua vita, si misura e si interroga sul valore e sul senso dell’esistenza, sul senso e sul valore della cultura, della religione, dell’ideologia anche e sulla tradizione, che risulta poi - in ultima istanza - una specie di forza centripeta dalla quale fugge, per poi, ciclicamente e ineluttabilmente, tornare . E’ un dato che i due tomi di “Tutte le poesie” (a cura di Walter Siti) possono solo aver confermato.
Da “Poesia in forma di rosa”, un componimento piuttosto scandaloso (per coloro che ottusamente avevano confuso Dio con la storia e, corpi morti, si affidavano ai destini progressivi dell’umanità) ha generato molti equivoci, ma è “semplicemente” una consapevole e disperata dichiarazione di poetica che risponde al suo sentirsi estraneo a un presente sempre più omologato, e a un futuro su cui pesa una pericolosa ipoteca di desertificazione culturale e valoriale.
Io sono una forza del Passato.
Solo nella tradizione è il mio amore.
Vengo dai ruderi, dalle chiese,
dalle pale d'altare, dai borghi
abbandonati sugli Appennini o le Prealpi,
dove sono vissuti i fratelli.
Giro per la Tuscolana come un pazzo,
per l'Appia come un cane senza padrone.
O guardo i crepuscoli, le mattine
su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo,
come i primi atti della Dopostoria,
cui io assisto, per privilegio d'anagrafe,
dall'orlo estremo di qualche età
sepolta. Mostruoso è chi è nato
dalle viscere di una donna morta.
E io, feto adulto, mi aggiro
più moderno di ogni moderno
a cercare fratelli che non sono più.
Le ragioni di una certa difficoltà di posizionamento sociale e politico di Pasolini polemista (sempre contro la morale comune, contro il movimento del Sessantotto, le posizioni anti-abortiste, il profondo senso religioso, l’anti-ideologismo e contro la modernità senza progresso), sono l’altra faccia della medesima medaglia dell’interna perenne lacerazione tra rispetto e amore per la letteratura e il suo ideologico e razionale rifiuto o superamento. A mio avviso viene così, guardando a Pasolini poeta, molto più facile rintracciare i motivi più autentici di quella che potrebbe sembrare fondamentalmente una forma di schizofrenia, di contraddittorietà e di divisione che altrimenti - isolata come dato quasi caratteriale - indebolirebbe tanto l’opera, quando l’uomo. Del resto buona parte delle analisi sulla sua opera puntano su questo dato, evidente a livello “psichico-tematico” come a quello formale, visto che l’ossimoro è una delle figure più costanti, tanto del suo ragionare che versificare.
L’appassionato equivoco in cui Pasolini poeta civile e Pasolini cittadino caddero, è, a mio parere, il medesimo in cui inciampò Ezra Pound, e, per dirla tutta, ancor prima cadde Dante. Pur a vario titolo padri della modernità, Pound, Dante e Pasolini ebbero sistematicamente lo sguardo rivolto al passato, laddove la storia è stata traumaticamente e irrimediabilmente strappata. Poeti della diaspora, con il mito della tradizione e della storia, si trovarono, loro malgrado, fuori dal tempo. Pier Paolo Pasolini è stato l’ultimo poeta civile del Novecento, e con passione (e ideologia) volle scommettere sul futuro dell’umanità, ma alla visione e la consapevolezza di un’ineluttabile frattura con la radici, con il passato e con la terra; fu allo stesso tempo rivoluzionario e conservatore. Come specularmene, Pound, fu conservatore e rivoluzionario.
Sul piano squisitamente formale e linguistico, Pasolini è “un ogni cosa”, una forza generatrice strabordante che, volta per volta cerca un contenitore adeguato. Se non venissi equivocato, direi che è una sorta di “rigattiere” della lingua e delle forme metriche. Nella sua produzione poetica c’è tutto: dialetto colto, recupero di forme tardo ottocentesche, prosa poetica e poesia prosastica. Eppure Pasolini non è privo di un suo stile: quello che sembra tenere assieme forme e ragionamenti apparentemente contrastanti e distanti è il vigore creativo, o meglio, la vita nella sua ampiezza e nella sua tragicità. Per Pasolini sembra non ci sia mai parola sufficientemente capace di contenere il concetto, mai metro abbastanza duttile: prova tutti i registri e li abbandona alla loro combustione. Sempre perfettamente irrisolto (non è per parodia, ma Pasolini obbliga all’ossimoro) egli sembra voler incapsulare nelle parole la vita, per poi costatarne il tremendo fallimento. La letteratura non adempie il compito sperato di sostituire la vita. Qualcosa rimane fuori, inerme e inespresso. Una perenne rincorsa e un composto affanno. Pasolini non si accontenta, cambia, rimesta le forme in un rovello tragico tanto per il poeta che per l’uomo. Così, tutta la sua intera avventura intellettuale, e in particolar modo poetica, pare segnata da un’ irrisolvibile ferita interiore, tanto sanguinante e viva da diventare essa stessa fonte di ispirazione, di forza visionaria e di poesia.
Pasolini poeta, in fondo, è anche pittore (non solo perché dipinse), non è inconsueto, infatti, trovare nei suoi versi (nel suo cinema è evidentissimo) l’influsso della grande pittura italiana del trecento, dell’Umanesimo e del Rinascimento. La sua poesia, in alcuni casi, sembra la conversione linguistica di spazi e volumi, e il colore, quasi sempre evocato attraverso similitudini, oppure trasformato nel valore simbolico, per esprimere la realtà attraverso analogiche aggettivazioni, dona al lettore una specie di choc e un viatico per penetrare oltre la scorza apparente delle cose, verso più segrete e inalienabili realtà primigenie. E’ la lezione di Roberto Longhi (a cui deve tanto anche per certe invenzioni linguistiche), impartita durante gli studi universitari, molto probabilmente a sopravvivere nel tempo e nel linguaggio di Pasolini. Solo a titolo d’esempio un brano da “La ricchezza” (tratto da “La religione del mio tempo”). A parte l’amore per Piero della Francesca, è interessante notare che Pasolini descrive un’opera d’arte, non come mera immagine, ma ritrae, piuttosto, l’espressione contenuta nell’immagine e l’unità sincronica delle stessa (l’eterno presente), si trasferisce nella dimensione temporale e lineare del linguaggio.
(…)
Quelle braccia d'indemoniati, quelle scure
schiene, quel caos di verdi soldati
e cavalli violetti, e quella pura
luce che tutto vela
di toni di pulviscolo: ed è bufera,
è strage. Distingue l'umiliato sguardo
briglia da sciarpa, frangia da criniera;
il braccio azzurrino che sgozzando
si alza, da quello che marrone ripara
ripiegato, il cavallo che rincula testardo
dal cavallo che, supino, spara
calci nella torma dei dissanguati.
(…)
Pasolini, insomma, insegue la realtà, in tutte le sue manifestazioni e forme. Insegue anche la finzione culturale della realtà perchè - tutto sommato - è il meglio che essa offre e, sembra inventarsi per davvero un nuovo modo di fare poesia. E’ la poetica dell’urgenza di capire e dire (anche facendo saltare i rapporti tra contenuto e forma) che lo contraddistingue, tutto sommato, ancor più che gli esperimenti filologici in dialetto (“La meglio gioventù”), le terzine pseudo-dentesche, o neo-pascoliane (“Le ceneri di Gramsci”). Molto più dell’informale-giornalistico di “Trasumanar e organizzar”. Voglio dire che, al di là delle forme, i motivi dell’ispirazione in Pasolini rimangono, in fin dei conti, sempre piuttosto immutati e lineari.
Pasolini inizia la sua avventura poetica in dialetto, forte di studi e robuste letture di filologia. Tra le “Poesie a Casarsa” (1942) e “La meglio gioventù” (1954), tenta di individuare e costituire una lingua poetica che è voce di una verità primigenia, insieme romanza e cristiana. E’ un’avventura intellettuale ardua, che non poteva trovare altra realizzazione se nella poesia, nella lingua e nella letteratura. Ci fu, con tutta evidenza un “non abbastanza” e Pasolini sentì l’esigenza di vita, di unità tra opera e esistenza reale. Si gettò in un’opera immane di attraversamento della realtà per tentare, in fin dei conti, di dominare per forza poetica, internamente, tutto il reale. E’quindi comprensibile lo scarto che gli fa scegliere, di li, a partire da “L’usignolo della Chiesa Cattolica”, (1958, ma i testi sono del 1943-1949), la lingua italiana anche come mezzo espressivo più politicamente orientato. Tentare di tenere assieme il sogno pre-ideologico e la necessità, l’urgenza di un discorso politico; la letteratura, in fondo, e il suo rifiuto; è il crisma di tutta la produzione di Pasolini, che negli anni a seguire, tormentatamene, consumò le scorie della stessa ideologia nella folgorante e incontestabile evidenza del linguaggio poetico. E non mi pare un caso - come vedremo - che al dialetto de “La nuova gioventù” (pubblicato l’anno successivo alla sua morte) egli tornò.
A me pare che ne “Le ceneri di Gramsci”, assieme , come abbiamo visto, in parti de “La religione del mio tempo”, questo tentativo di mediazione tra “alto” e “basso”, tra descrizione reale e spinte sociali, tra vita e storia, insomma, sia formalmente e concettualmente riuscito. In “Poesia in forma di rosa” (1964) e in “Trasumanar e organizzar” (1971), bisogna piuttosto saper cercare testi (che pure sono presenti) capaci di far risuonare nella cassa armonica di una versificazione eccessivamente prosaica, quella che Pasolini stesso chiama “disperata vitalità”. Già, il meglio ancora in un ossimoro!
Riporto qui di seguito la prima parte del poemetto “Il pianto della scavatrice” presente ne “Le ceneri di Gramsci”. Irrompe nei versi la nuova realtà storica del sottoproletariato romano che il Pasolini vuole rappresentare, anzi di fotografare all’interno di quello che egli stesso definisce unInferno. Il tema centrale è l'alternarsi di speranzae disperazione che alla fine, nel “Pianto della scavatrice”, appunto, diventa accettazione dolorosa delle ferite provocate dai cambiamenti storici e sociali. Esprimere caratteri logici,storicie razionaliutilizzando strumenti linguistici pre-novecenteschi, è un azzardo formale che paga in termini di equilibrio tra un certa propensione all’oratoria e alla retorica e la spinta lirica, autentica e drammatica. L’incipit, a mio avviso, è tra i più belli della poesia italiana dello scorso Secolo. E’ un inno alla militanza dei sentimenti, i quali sono veri solo se incarnati nella vita, proprio come le idee. E’ un comunismo, quello di Pasolini, non a caso gramsciano: popolare e intriso di sentimento nazionale.
Solo l'amare, solo il conoscere
conta, non l'aver amato,
non l'aver conosciuto. Dà angoscia
il vivere di un consumato
amore. L'anima non cresce più.
Ecco nel calore incantato
della notte che piena quaggiù
tra le curve del fiume e le sopite
visioni della città sparsa di luci,
scheggia ancora di mille vite,
disamore, mistero, e miseria
dei sensi, mi rendono nemiche
le forme del mondo, che fino a ieri
erano la mia ragione d'esistere.
Annoiato, stanco, rincaso, per neri
piazzali di mercati, tristi
strade intorno al porto fluviale,
tra le baracche e i magazzini misti
agli ultimi prati. Lì mortale
è il silenzio: ma giù, a viale Marconi,
alla stazione di Trastevere, appare
ancora dolce la sera. Ai loro rioni,
alle loro borgate, tornano su motori
leggeri - in tuta o coi calzoni
di lavoro, ma spinti da un festivo ardore
i giovani, coi compagni sui sellini,
ridenti, sporchi. Gli ultimi avventori
chiacchierano in piedi con voci
alte nella notte, qua e là, ai tavolini
dei locali ancora lucenti e semivuoti.
Stupenda e misera città,
che m'hai insegnato ciò che allegri e
feroci
gli uomini imparano bambini,
le piccole cose in cui la grandezza
della vita in pace si scopre, come
andare duri e pronti nella ressa
delle strade, rivolgersi a un altro uomo
senza tremare, non vergognarsi
di guardare il denaro contato
con pigre dita dal fattorino
che suda contro le facciate in corsa
in un colore eterno d'estate;
a difendermi, a offendere, ad avere
il mondo davanti agli occhi e non
soltanto in cuore, a capire
che pochi conoscono le passioni
in cui io sono vissuto:
che non mi sono fraterni, eppure sono
fratelli proprio nell'avere
passioni di uomini
che allegri, inconsci, interi
vivono di esperienze
ignote a me. Stupenda e misera
città che mi hai fatto fare
esperienza di quella vita
ignota: fino a farmi scoprire
ciò che, in ognun, era il mondo.
Una luna morente nel silenzio,
che di lei vive, sbianca tra violenti
ardori, che miseramente sulla terra
muta di vita, coi bei viali, le vecchie
viuzze, senza dar luce abbagliano
e, in tutto il mondo, le riflette
lassù, un po' di calda nuvolaglia.
È la notte più bella dell'estate.
Trastevere, in un odore di paglia
di vecchie stalle, di svuotate
osterie, non dorme ancora.
Gli angoli bui, le pareti placide
risuonano d'incantati rumori.
Uomini e ragazzi se ne tornano a casa
- sotto festoni di luci ormai sole -
verso i loro vicoli, che intasano
buio e immondizia, con quel passo blando
da cui più l'anima era invasa
quando veramente amavo, quando
veramente volevo capire.
E, come allora, scompaiono cantando.
Sempre non del tutto risolto e teso tra due soluzioni del problema, Pasolini, da una parte, con l'impegno di una volontà tutta intellettuale, andava verso una doverosa presa di coscienza ideologica, alla composizione di un’opera che fosse partecipe alla lotta di classe; dall’altra, attraverso soprattutto la via poetica, ravvisava una diversa, arcaica, remota verità. La verità che non è la storia. Una verità al suo stato ancestrale e puro, pre-ideologico, inalienabile, originaria e primigenia, che nulla aveva a che fare con la prassi marxista.
E’ all’interno di questa immensa contraddizione, o meglio in questa dinamica di continua tensione e negli stappi a volte conseguenti, che Pasolini trova l’energia mentale e morale con cui riempie i suoi versi e le sue giornate (fino all’ultimo) nel mondo. Se fin ora abbiamo (superficialmente) parlato di tensioni intellettuali, poetiche, civili e letterarie; un capitolo a parte andrebbe scritto sul rapporto che Pasolini ha avuto con il sacro. Con la religiosità. A quanto pare, sacra, per Pasolini, è la stessa realtà. Ma ciò che è di più sacro è l’origine a cui tutto è debitore e a cui tutto dovrebbe, in linea di principio, tornare. Un’idea di tempo ciclico di ascendenza pagana, quella del poeta di Casarsa, intrecciata con un cristianesimo rurale e cosmico.
Ma anche in questo contesto Pasolini spesso prova a far migrare il proprio cristianesimo in una dimensione politica. Da una parte le polemiche con le gerarchie della Chiesa di Roma, dall’altra, le battaglie pubbliche per la difesa della vita, contro l’aborto che non sono ascrivibili ad una idea confessionale della religione, quanto a quel grande quadro di degrado consumistico in cui la società stava perdendo le proprie la radici e la propria dignità. La vita è riconosciuta da Pasolini come dono: più che contro la pratica dell’aborto, egli (memorabili le “Lettere luterane”) si scagliò contro il sesso degradato a merce e consumo.
“C’è un’ideologia reale e incosciente - scrisse - che unifica tutti: è l’ideologia del consumo”. E ancora : “Ora che posso fare un paragone, mi sono reso conto di una cosa che scandalizzerà i più, e che avrebbe scandalizzato anche me, appena dieci anni fa. Che la povertà non è il peggiore dei mali, e nemmeno lo sfruttamento. Cioè, il gran male dell’uomo non consiste né nella povertà, né nello sfruttamento, ma nella perdita della singolarità umana sotto l’impero del consumismo.”
Mi congedo con l’ultima poesia di Pasolini scritta in lingua friulana e per questo tradotta per motivi di spazio. “Saluto e augurio”, pubblica ne “La nuova gioventù”. Un testamento, una preghiera civile. Un capolavoro.
È quasi sicuro che questa è la mia ultima poesia in friulano: e voglio parlare a un fascista, prima che io, o lui, siamo troppo lontani.
È un fascista giovane, avrà ventuno, ventidue anni: è nato in un paese ed è andato a scuola in città.
È alto, con gli occhiali, il vestito grigio, i capelli corti: quando comincia a parlarmi, penso che non sappia niente di politica
e che cerchi solo di difendere il latino e il greco contro di me; non sapendo quanto io ami il latino, il greco - e i capelli corti. Lo guardo, è alto e grigio come un alpino.
"Vieni qua, vieni qua, Fedro. Ascolta. Voglio farti un discorso che sembra un testamento. Ma ricordati, io non mi faccio illusioni
su di te: io so, io so bene, che tu non hai, e non vuoi averlo, un cuore libero, e non puoi essere sincero: ma anche se sei un morto, io ti parlerò.
Difendi i paletti di gelso, di ontano, in nome degli Dei, greci o cinesi. Muori d’amore per le vigne. Per i fichi negli orti. I ceppi, gli stecchi.
Per il capo tosato dei tuoi compagni. Difendi i campi tra il paese e la campagna, con le loro pannocchie abbandonate. Difendi il prato
tra l’ultima casa del paese e la roggia. I casali assomigliano a Chiese: godi di questa idea, tienla nel cuore. La confidenza col sole e con la pioggia,
lo sai, è sapienza sacra. Difendi, conserva, prega! La Repubblica è dentro, nel corpo della madre. I padri hanno cercato e tornato a cercar
di qua e di là, nascendo, morendo, cambiando: ma son tutte cose del passato. Oggi: difendere, conservare, pregare. Taci! Che la tua camicia non sia
nera, e neanche bruna. Taci! che sia una camicia grigia. La camicia del sonno. Odia quelli che vogliono svegliarsi, e dimenticarsi delle Pasque...
Dunque, ragazzo dai calzetti di morto, ti ho detto ciò che vogliono gli Dei dei campi. Là dove sei nato. Là dove da bambino hai imparato
i loro Comandamenti. Ma in Città? Là Cristo non basta. Occorre la Chiesa: ma che sia moderna. E occorrono i poveri
Tu difendi, conserva, prega: ma ama i poveri: ama la loro diversità. Ama la loro voglia di vivere soli nel loro mondo, tra prati e palazzi
dove non arrivi la parola del nostro mondo; ama il confine che hanno segnato tra noi e loro; ama il loro dialetto inventato ogni mattina,
per non farsi capire; per non condividere con nessuno la loro allegria. Ama il sole di città e la miseria dei ladri; ama la carne della mamma nel figlio
Dentro il nostro mondo, dì di non essere borghese, ma un santo o un soldato: un santo senza ignoranza, o un soldato senza violenza.
Porta con mani di santo o soldato l’intimità col Re, Destra divina che è dentro di noi, nel sonno. Credi nel borghese cieco di onestà,
anche se è un’illusione: perché anche i padroni hanno i loro padroni, e sono figli di padri che stanno da qualche parte nel mondo.
È sufficiente che solo il sentimento della vita sia per tutti uguale: il resto non importa, giovane con in mano il Libro senza la Parola.
Hic desinit cantus. Prenditi tu, sulle spalle, questo fardello. Io non posso: nessuno ne capirebbe lo scandalo. Un vecchio ha rispetto
del giudizio del mondo: anche se non gliene importa niente. E ha rispetto di ciò che egli è nel mondo. Deve difendere i suoi nervi, indeboliti,
e stare al gioco a cui non è mai stato. Prenditi tu questo peso, ragazzo che mi odii: portalo tu. Risplende nel cuore. E io camminerò leggero, andando avanti, scegliendo per sempre la vita,
la gioventù".
Piaciuto questo Articolo? Condividilo...
-
Inserito da piccolo il 03/11/2013 12:38:01
articolo lungo. prolisso. non bastava dire che l'autore, elegante corsaro della scrittura, ammirava Sabaudia, Piero della Francesca,la cultura contadina, e la poesia dialettale? in quest'ultima però aveva avuto una svista quando nell'antologia da lui compilata aveva obliato nome e composizioni di Berto Barbarani. l'elegante corsaro della scrittura ha avuto però un approdo deprimente. tutto qui. condensiamo.
-
Inserito da ghorio il 02/11/2013 18:16:07
Non ho niente contro Pasolini: i suoi scritti sul Corriere erano sempre interessanti e soprattutto erano contro il cosiddetto Palazzo, anche se lo scrittore militava a sinistra e di conseguenza c'era poco di essere controcorrente. Certo i suoi scritti corsari rappresentano una modo di scrivere elegante e polemico. Una considerazione, però, debbo farla, visto anche la citazione di un giudizio di Veneziani: nell'area di centro destra non vige il settarismo. Gli scrittori, i giornalisti, i registi si giudicano, a prescindere dalle loro idee, cosa che nell'area di centrosinistra non avviene quasi mai. Mishima, per esempio, sarà sempre uno scrittore reazionario. Vige sempre infatti per costoro la regola che gli altri, quelli che militano nel campo avverso, sono forcaioli e reazionari.
2 commenti per questo articolo
Cultura
Un concerto per il venerdì santo al teatro del Maggio, tra Bach e Rossini
Un don Pasquale da ... sposare. Un grande spettacolo al Maggio Musicale Fiorentino
DON PASQUALE : l'ultimo capolavoro buffo di Donizetti tra beffe, sospiri e un tocco di malinconia
NERONE: al teatro lirico di Cagliari rinasce un capolavoro
Così é se vi pare, una grande lettura del dramma di Pirandello. Pieno successo della versione di Geppy Gleijeses al teatro della Pergola